Matsutake, “il fungo alla fine del mondo” che insegna agli uomini a sopravvivere alle apocalissi
- Postato il 9 settembre 2025
- Ambiente
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
Quando, nel 1991, l’Unione Sovietica si dissolve in una notte sola, e davanti a milioni di cittadini si spalanca l’ignoto, ai siberiani viene in mente solo una cosa per evitare la fame e il panico: andare nella foresta a cercare funghi. Nel 1945, dopo il fungo atomico di Hiroshima, i giapponesi raccontano che la prima cosa che ha saputo rinascere nell’inferno radioattivo è stata un altro fungo: il matsutake. La storia di questo rarissimo micete, che non può essere coltivato o piantato, ma sorge solo nelle terre devastate da inquinamento, disboscamento, guerre e veleni, la racconta Anna Lowenhaupt Tsing ne Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo (edizioni Keller).
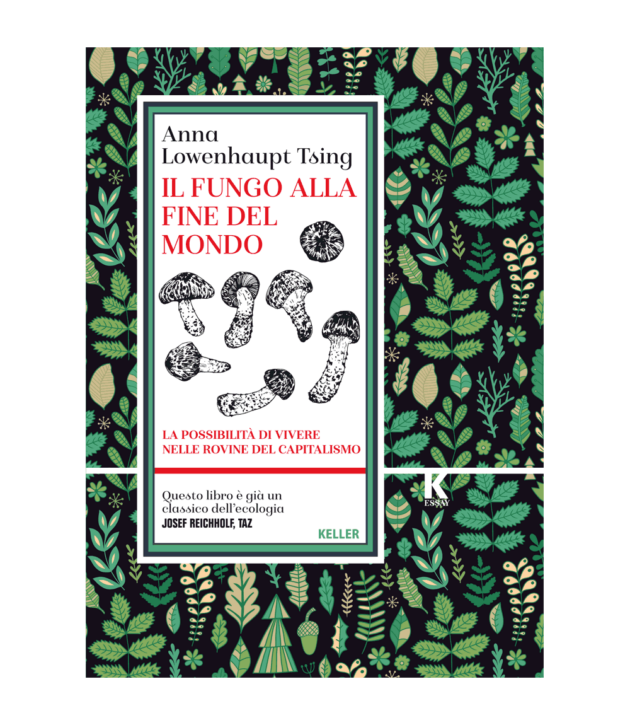 I matsutake nascono solo se qualcosa muore: prosperano dopo un disastro ecologico, sorgono solo dopo le apocalissi. La loro unica culla possibile è la distruzione altrui. Questi funghi sono gran maestri della sopravvivenza e rappresentano, scrive l’autrice, quell’ “imprevedibilità frammentaria associata alla nostra condizione”. La prima volta che i giapponesi si accorgono dell’esistenza di questo esemplare selvatico è quando abbattono gli alberi per costruire templi a Kyoto: nasce secoli e secoli fa l’ossessione per quelli che sono diventati oggi “i funghi più costosi della terra”, rarissimi, pregiatissimi e ricercatissimi nei mercati giapponesi e statunitensi.
I matsutake nascono solo se qualcosa muore: prosperano dopo un disastro ecologico, sorgono solo dopo le apocalissi. La loro unica culla possibile è la distruzione altrui. Questi funghi sono gran maestri della sopravvivenza e rappresentano, scrive l’autrice, quell’ “imprevedibilità frammentaria associata alla nostra condizione”. La prima volta che i giapponesi si accorgono dell’esistenza di questo esemplare selvatico è quando abbattono gli alberi per costruire templi a Kyoto: nasce secoli e secoli fa l’ossessione per quelli che sono diventati oggi “i funghi più costosi della terra”, rarissimi, pregiatissimi e ricercatissimi nei mercati giapponesi e statunitensi.
Per scrivere di questi incontrollabili anarchici dei boschi, come una Walden nata nel nostro secolo, Tsing si è incamminata nella foresta, ma, a differenza del protagonista del capolavoro di Henry David Thoreau, non si è potuta fermare in una capanna per scappare dalla società industriale: è stata obbligata, come tutta la sua generazione (e come il fungo giapponese), a sopravvivere tra le sue macerie. Tsing esplora non solo la vita del fungo, ma, attraverso essa, la condizione del mondo, le relazioni segrete e sotterranee del matsutake, che si nutre di alberi vivi e morti, quanto quelle dell’economia e delle condizioni di lavoro dei suoi raccoglitori. Si infila nei destini di frontiera, vite a margine che si nutrono degli scambi di “matsi” (in gergo li chiamano così). A cercare i matsutake sono soprattutto rifugiati asiatici e sudamericani, clandestini costretti a nascondersi: invisibili della società che cercano invisibili della foresta.
L’opera della professoressa di antropologia della University of California è un “organismo contaminato” come il vegetale di cui si occupa: un saggio scientifico in cui vengono innestati racconti, reportage e un’indagine che inizia in terra nipponica e finisce in quella statunitense, tra le foreste dell’Oregon. È una passeggiata chilometrica nei labirinti fungini dove dal sottosuolo emerge non solo la catastrofe biologica, ma anche quella psicologica di una generazione che si crede ultima. I tempi del racconto e quelli del raccolto viaggiano paralleli nell’esplorazione della precarietà che non è solo della natura, ma dell’uomo nell’era della globalizzazione. Dalle parole di raccoglitori e i rivenditori che incontrerà lungo le rotte del commercio di questi funghi che raggiungono prezzi stellari da Tokyo a Washington, la scrittrice trae una conclusione: tutto, intorno a noi, è precario. Stiamo vivendo quel momento della storia in cui la condizione dell’ambiente e quella dell’umanità si assomigliano come mai prima e, anche noi, come i funghi, siamo costretti ad abitare sull’orlo dell’apocalisse. Così il matsutake può insegnarci qualcosa: “Esistono ancora piaceri tra i terrori dell’indeterminazione” e prosperare nelle rovine è l’unica forma di resistenza rimasta.
L’ecologia, in letteratura, nasce ancor prima che venga inventata la parola che indica “lo studio delle relazioni tra organismi e ambiente circostante”: la conia nel 1866 il biologo tedesco Ernst Haeckel, ma ci vorrà circa un secolo prima che un libro, più degli altri, riesca ad aprire un varco per imporla all’attenzione del dibattito pubblico mondiale. Sono le pagine di Primavera silenziosa di Rachel Carson a diventare subito manifesto di quel movimento ambientalista che trasformerà l’ecologia, da scienza, in coscienza collettiva, negli anni ’60. Da lì in poi, le catastrofiche conseguenze dell’intervento umano nell’ambiente che lo ospita, finiranno sempre più spesso sugli scaffali delle librerie, prime pagine dei giornali e podcast e documentari nel web.
Ma se nella sua ossessione di scovare soluzioni in un’orizzonte sempre più oscuro, finora tutta la saggistica ecologica è stata tradita dalla sua ricerca di redenzione, di una soluzione che consentirà all’uomo e all’ambiente di coesistere in pace, l’opera Tsing compie una scelta radicale e diversa: l’autrice dichiara estinta l’idea stessa di salvezza. Distrugge ogni illusione per sostituirla con una concreta verità: intorno abbiamo solo le macerie nate dal collasso del sistema economico e climatico. Di queste, uomini e funghi, sono entrambi figli, ma solo uno si è già abituato al nuovo habitat: il matsutake, “il fungo alla fine del mondo” che diventa simbolo di resurrezione dalla morte. La sua stessa esistenza è la prova che non andrà tutto bene, ma comunque andrà, e “non abbiamo altra scelta che trovare vita tra queste rovine”. Non abbiamo altra scelta se non quella di diventare anche noi rare, preziosissime e inaspettate conseguenze della foresta.
L'articolo Matsutake, “il fungo alla fine del mondo” che insegna agli uomini a sopravvivere alle apocalissi proviene da Il Fatto Quotidiano.


