Il pollice verde degli antichi egizi: dai giardini domestici a quelli nel deserto, ecco perché erano così bravi
- Postato il 26 agosto 2025
- Ambiente
- Di Il Fatto Quotidiano
- 2 Visualizzazioni
.png)
Oggi siamo abituati a pensare all’antico Egitto come un luogo duro, arido e inospitale. Al contrario, era un territorio composto da diversi ecosistemi, che ospitavano fiori, piante e arbusti di ogni tipo. A rovesciare un luogo comune e introdurci nel mondo affascinante dei giardini egizi è l’egittologa e divulgatrice scientifica del Museo Egizio a Torino Divina Centore, autrice del libro Faraoni e fiori. La meraviglia dei giardini dell’antico Egitto (Il Mulino). “È stata la straordinaria capacità degli antichi egizi di gestire le risorse idriche a fare la differenza”, spiega. “Grazie a un’innovazione senza precedenti, all’irrigazione e alla costruzione di canali, sono riusciti a massimizzare l’utilizzo delle acque del Nilo, permettendo loro di alimentare un’agricoltura sostenibile e di supportare una società̀ complessa e avanzata”.
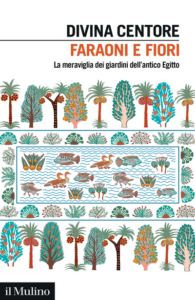 Può spiegarci in che modo?
Può spiegarci in che modo?
Era fondamentale monitorare l’andamento delle inondazioni del fiume: un livello d’acqua troppo basso poteva significare carestia, mentre un livello eccessivo comportava il rischio di distruzione dei raccolti. Per farlo, gli Egizi utilizzavano i nilometri, strumenti semplici ma efficaci, dotati di scale graduate che scendevano fino al fiume. La stagione delle inondazioni (Akhet) durava circa quattro mesi e, una volta ritirate le acque, iniziava il periodo della crescita (Peret), durante il quale i contadini aravano i campi e piantavano i semi per i raccolti futuri. Quattro mesi dopo, gli Egizi celebravano la stagione del raccolto (Shemu), un evento sacro legato alla dea Renenutet, rappresentata con la testa di un cobra e conosciuta come la “Signora del granaio”.
Tornando ai giardini. Come si presentava un tipico giardino egizio?
Immaginiamo uno specchio di acqua al centro del giardino pieno di fiori come le ninfee; tutto intorno c’era una vegetazione spondale che diventava sempre più alta mano a mano che ci si allontanava dall’acqua. E poi file di alberi organizzati in maniera simmetrica, dal valore tanto pratico quanto simbolico. In generale, il giardino egizio era caratterizzato da una disposizione armoniosa e simmetrica, progettata per creare un ambiente ordinato e sereno.
Lei racconta come ci fossero diversi tipi di giardini a seconda dei ruoli e dei contesti.
Nel caso dei giardini progettati per perpetuare il culto regale del faraone, la disposizione di alberi, fiori e d’acqua era studiata per simboleggiare il legame tra il faraone divinizzato e la natura rigeneratrice. Immaginiamo che potessero ospitare piante come palme e sicomori indigeni, ma anche alberi di mirra e incenso. I giardini funerari invece erano spazi simbolici che accompagnavano il defunto nel suo viaggio verso la vita eterna. Da tracce archeologiche sappiamo che venivano costruiti nei pressi della tomba, quindi in pieno deserto. La loro struttura era quindi pensata per trattenere l’umidità, per ovviare all’assenza di acqua. E poi c’erano i giardini in contesti abitativi.
Soprattutto per le persone abbienti?
Sì. Erano spazi di piacere e ristoro, ideati per donare frescura e pace alla vita domestica, con una funzione sia estetica che pratica: offrivano ristoro dall’afa del deserto, e non mancavano alberi da frutto, orti e piante aromatiche, apprezzati per il loro profumo e utilizzati per la cucina e la medicina domestica. Molte piante erano anche importate, riflettendo con la loro presenza la ricchezza dei proprietari del giardino.
Ma come siamo arrivati ad avere notizie dettagliate di questi giardini?
Le pitture conservate nelle tombe ci mostrano giardini privati e templari animati, con piante in fiore e alberi carichi di frutti, in una perenne primavera. La letteratura dona voce alle piante, fornendoci preziose informazioni sulla loro cura e provenienza. Sebbene incompleti, sono giunti a noi anche frammenti di erbari, su papiro e su pietra. E il tutto dialoga ovviamente con le evidenze archeologiche, in un’armonia dove partecipa anche l’archeobotanica, che studia i resti delle piante aiutandoci ad identificarne la specie. Vorrei raccontare una curiosità.
Prego.
Nelle pitture raffiguranti i giardini ritrovate nelle tombe non compaiono animali selvatici, probabilmente perché gli Egizi desideravano rappresentare un ambiente puro e ordinato. Pesci e uccelli erano gli unici animali raffigurati, forse come simbolo di abbondanza o come offerta per il defunto.
E i giardinieri? Che vita facevano?
I giardinieri egizi si distinguevano per competenze e responsabilità: da chi svolgeva le mansioni fisiche quotidiane a chi aveva incarichi più “manageriali”. Per i primi il lavoro era duro e logorante, bisognava affrontare inondazioni, siccità e animali infestanti di ogni tipo, ma soprattutto portare acqua sulle spalle, insomma “un lavoraccio”.
Gli egizi sono noti per aver usato le piante in moltissimi modi, dalla cosmesi alla medicina.
Sì, esatto, fiori e piante venivano utilizzati nella cosmesi egizia – il make-up non era solo per il mondo femminile ma anche maschile – ma per creare creme antirughe e per la detersione, oltre a prodotti per i capelli, per la depilazione e oli e unguenti. Infine, molti degli alimenti consumati dagli egizi crescevano proprio nei giardini, creando una connessione diretta tra il giardino e il mondo della tavola, ma anche con la medicina.
Lei scrive che gli Egizi sapevano che la prosperità della loro società dipendeva da una gestione oculata delle risorse naturali. Abbiamo perso questa consapevolezza?
La straordinaria capacità di adattamento ha permesso agli Egizi di affrontare con successo le sfide climatiche e ambientali che si sono presentate nel corso dei secoli. Se loro sono riusciti a creare giardini in un ambiente tanto difficile, non abbiamo più scuse per non farlo anche noi. I giardini, infatti, sono sempre stati il riflesso della civiltà che li ha realizzati: se un tempo rappresentavano potere e prestigio, oggi le nostre aree verdi assumono un nuovo significato. Non sono soltanto spazi di bellezza, ma diventano simboli di resistenza ecologica, luoghi di rifugio per la biodiversità e strumenti essenziali per la mitigazione del cambiamento climatico.
L'articolo Il pollice verde degli antichi egizi: dai giardini domestici a quelli nel deserto, ecco perché erano così bravi proviene da Il Fatto Quotidiano.



