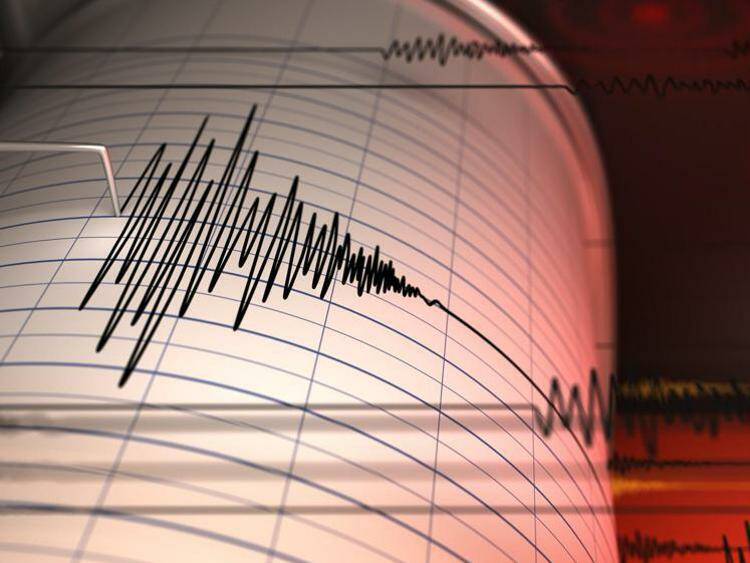Cosa succede quando la scienza, che hai sempre raccontato con rigore e lucidità, ti presenta il conto e ti scaraventa dall'altra parte della barricata? Beatrice Mautino, spinta da una vicenda familiare che la costringe a confrontarsi con la malattia, ci prende per mano e ci accompagna nella sua "Vertigine". È il disorientamento di chi, abituato a maneggiare dati e certezze, si ritrova a fare i conti con la speranza, la paura e un sistema sanitario complesso. Il risultato è un libro straordinario, che unisce il calore della narrazione personale alla chiarezza cristallina della migliore divulgazione.
Per i lettori di Focus, "Vertigine" è una lettura irrinunciabile per almeno due motivi. Primo, Mautino ha un talento raro nello smontare e spiegare argomenti complessi, dalla frontiera della terapia genica al funzionamento dei nuovi farmaci per l'obesità, con una profondità che soddisfa la curiosità scientifica senza mai diventare accademica. Secondo, il libro è un potente manuale di scetticismo applicato: analizzando casi emblematici come Stamina, il metodo Di Bella o le derive del mondo del benessere, ci insegna a riconoscere le trappole della disinformazione e a usare gli strumenti del pensiero critico proprio quando le emozioni rischiano di prendere il sopravvento. È un'esplorazione onesta e necessaria del nostro tempo, che ci restituisce una fiducia più matura nella scienza e, soprattutto, in noi stessi.
A seguire, vi proponiamo un estratto del libro (© Mondadori):. Che cos'è l'osteopatia
L'osteopatia gode di un'immagine "naturale" e sicura, che ci porta ad abbassare le difese critiche. Ma cosa c'è dietro le manipolazioni e gli "scrocchi" che spopolano sui social? L'estratto analizza i rischi, spesso sottovalutati, di queste pratiche, confrontandoli con il rigore richiesto alla medicina tradizionale. Un viaggio alle origini della disciplina, fondata da Andrew Taylor Still dopo una tragedia familiare, per chiederci perché trattiamo con più indulgenza una pratica che può avere effetti avversi anche gravi.
L'osteopatia viene percepita come una forma di medicina più naturale, in grado di riequilibrare il corpo senza bisogno di medicinali o procedure che associamo alla medicina tradizionale. Come tutte le cose che percepiamo come più naturali, ci sembra anche potenzialmente meno dannosa e quindi abbassiamo le nostre difese critiche. Non mettiamo in conto i possibili effetti collaterali con lo stesso metro che usiamo, magari a malincuore, per un farmaco o un intervento chirurgico. Ci lasciamo sedurre dalla promessa di benessere, dalla manualità, dalla liberazione immediata del blocco, dal racconto aneddotico. Scegliamo con più leggerezza, magari basandoci proprio su quei video visti sui social, senza chiederci più di tanto se abbiano un reale senso terapeutico e se chi li esegue abbia una formazione adeguata e si assuma la responsabilità del proprio operato.
Eppure i rischi ci sono. Dall'analisi degli studi di tipo epidemiologico effettuati nel corso degli anni sappiamo che circa la metà di tutte le manipolazioni cervicali e spinali provocano degli effetti avversi. Nella stragrande maggioranza dei casi sono lievi e transitori, come mal di testa o disagio nella zona trattata. In alcuni casi, invece, le cose si complicano. La probabilità di avere un problema grave [...] aumenterebbe di cinque volte nella settimana successiva allo «scrocchiamento», con una stima al ribasso dovuta alla difficoltà di mettere in correlazione diretta i due eventi.
Non c'è un consenso netto al riguardo. Ci sono studi che dimostrano un rischio anche elevato e altri che invece ridimensionano la questione. I punti fermi sono che il rischio c'è ed è spesso dipendente dall'operatore. Succede di meno se l'osteopata è anche fisioterapista o medico, succede di più se a praticare la manipolazione spinale è una figura che non ha una formazione sanitaria adeguata. Questo dato rinforza la necessità di cautela, ma anche l'importanza di rivolgersi a professionisti sanitari con una formazione rigorosa e riconosciuta, quando si considerano trattamenti che coinvolgono il tratto cervicale.
Il giornalista scientifico britannico Simon Singh, in un articolo pubblicato sul quotidiano «The Guardian», ha scritto che «se la manipolazione spinale fosse un farmaco con effetti avversi così gravi e così pochi benefici dimostrabili, allora sarebbe stato quasi certamente ritirato dal mercato». Una posizione molto forte, per la quale aveva ricevuto una querela per diffamazione da parte dell'associazione dei chiropratici inglesi, poi ritirata, ma che presenta un punto fondamentale. Se è una pratica con rischi anche gravi, perché la trattiamo diversamente, con più indulgenza, dalle pratiche mediche?
«Il nostro obiettivo è stato sempre quello di arrivare a una definizione dell'osteopatia come professione sanitaria,» mi spiega Paola Sciomachen, che con il ROI ha portato avanti un percorso decennale e molto accidentato per il riconoscimento legislativo, «con tutti gli obblighi del caso, professionali, deontologici ed etici.»
Le ossa del dottor Still
Vale quindi la pena provare a capire come siamo arrivati a questo punto. L'osteopatia è una pratica nata ben prima dei social media, e oggi si trova al centro di reazioni polarizzate: da un lato un'enorme popolarità e fiducia da parte di molti pazienti, dall'altro dubbi scientifici consistenti, rischi reali e un percorso di riconoscimento istituzionale non ancora terminato. Per provare a capirlo dobbiamo avventurarci in un viaggio indietro nel tempo alle origini dell'osteopatia.
Il nostro viaggio inizia centocinquant'anni fa tra il Kansas e il Missouri, in mezzo a quelli che sarebbero diventati gli Stati Uniti che conosciamo oggi. Andrew Taylor Still è un giovane aspirante medico che è stato arruolato come assistente ospedaliero in un battaglione delle forze unioniste che combattevano contro la cosiddetta Confederazione nella Guerra civile americana.
Quella di Still è una di quelle storie densissime di chi vive in un territorio di frontiera, tra una medicazione improvvisata a un soldato e uno scontro con serpenti e tassi, come scrive nelle oltre cinquecento pagine della sua autobiografia. La frontiera, per Still, è la fonte stessa della conoscenza, è un buon luogo per trovare la verità perché «non c'è nessuno a disturbarti». È qui, molto più che all'università, che pensa di dedicarsi allo studio del «grande libro della natura», osservando gli animali selvatici e analizzando i resti di migliaia di corpi di indigeni esumati «fino a diventare completamente familiare con ogni osso del corpo umano».
Andrew Taylor Still sarebbe potuto diventare un naturalista, ma nella primavera del 1864 successe qualcosa che cambiò per sempre la sua storia e, per certi versi, anche la nostra. «Un nuovo nemico fece la sua comparsa» leggiamo nel racconto di quei tragici momenti, un nemico che gli fa rimpiangere addirittura la guerra che, in confronto, era stata misericordiosa nei confronti della sua famiglia. Tre dei suoi figli vennero colpiti dalle «oscure ali della meningite», i medici provarono a curarli con i rimedi disponibili all'epoca, i sacerdoti offrirono conforto e preghiere, «ma tutto fu vano». I bambini morirono e Still iniziò a fare quello che facciamo tutti di fronte alle tragedie: cercarne il senso. O costruirlo.
È possibile, si chiedeva, che Dio ci abbia lasciati soli «in un mondo di supposizioni»? Dobbiamo ipotizzare quale sia la causa di una malattia, quale possa esserne la soluzione e anche immaginarci il risultato. E magari, poi, quando qualcuno muore, pensare anche a dove andrà la sua anima. «In quel momento» scrive Still «decisi che Dio non era un Dio di supposizioni, ma un Dio di verità.»
È con questo pensiero che inizia la storia di quella disciplina che oggi conosciamo con il nome di osteopatia, dall'unione delle parole greche osteon (ossa) e pathos (dolore, sofferenza). Still si convinse che le malattie dell'organismo siano strettamente legate a problemi dell'apparato muscolo-scheletrico e che di conseguenza si debba intervenire su quest'ultimo per rimettere le cose a posto e tornare in salute. Confidando che un Creatore amorevole e intelligente avesse posto nel corpo umano i rimedi per curare ogni malattia, Still si concentrò sulla ricerca delle condizioni giuste affinché questi rimedi potessero combinarsi tra loro per alleviare le sofferenze ed elaborò le sue teorie, chiedendo ai propri pazienti di non sottoporsi alla medicina tradizionale e di seguire i suoi consigli. Un atteggiamento che oggi definiremmo «da ciarlatano», ma dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di un secolo e mezzo fa, quando la medicina era molto diversa da quella che conosciamo oggi, piena di rimedi che non erano davvero tali, di pozioni contenenti sostanze tossiche e di approcci privi di valenza scientifica. Succedeva, quindi, che le cure potessero causare più danni della malattia stessa.
In un contesto come questo, l'approccio di Still, che prevedeva particolari manipolazioni del corpo il cui scopo era quello di ripristinare l'armonia nell'organismo per favorire la guarigione, poteva davvero risolvere alcuni problemi, se non altro quelli che sarebbero comunque passati da soli. In venticinque anni di lavoro, Still raccolse proseliti e rese più elaborate le sue teorie, a partire dall'idea che la struttura e la funzione siano collegate tra loro nell'organismo e che ogni parte del corpo sia essenziale per la sua armoniosità. Nel 1892 fondò la Scuola americana di osteopatia e nello stesso anno pubblicò un libro che spiegava le varie pratiche. Poco dopo, lo spiritista Daniel David Palmer, forse ispirato dal lavoro di Still, sviluppò la chiropratica, una teoria secondo la quale il disallineamento delle ossa, specialmente nella colonna vertebrale, è la causa di vari malesseri, da quelli specifici dell'apparato muscolo-scheletrico alle condizioni più disparate, come le malattie cardiovascolari o, addirittura, la sordità.
La comunità scientifica dell'epoca accusò Still di non aver condotto esperimenti controllati per dimostrare l'efficacia dei suoi trattamenti. Tuttavia, quelle idee erano affascinanti e trovarono via via sempre più sostenitori, condizionando a lungo il modo non solo di fare, ma anche di regolamentare la medicina, prima negli Stati Uniti, poi in Italia. [...].