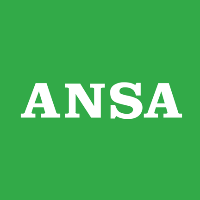Vendite selvagge sui social network: il Far West digitale finisce nel mirino del Fisco
- Postato il 22 novembre 2025
- Di Panorama
- 2 Visualizzazioni


Quando chiediamo se, a fronte dell’acquisto, emettono una ricevuta, scappano tutti. Non rispondono, e in alcuni casi bloccano. È questo il Far west digitale che quotidianamente va in scena sui social network, dove quella che fino a pochi anni fa era una semplice vetrina di passioni (mixata a protagonismo), oggi è diventata una piazza d’affari multimiliardaria, disponibile 24 ore su 24 dal proprio divano.
TikTok, Instagram e piattaforme Consumer-to-Consumer (C2C), in cui cioè il consumatore vende direttamente a un altro consumatore (come Vinted) hanno trasformato milioni di utenti in negozianti, spesso inconsapevoli delle implicazioni (a cominciare da quelle fiscali) delle loro attività.
Il bazar infinito tra hobby e impresa
Dopo i 15 minuti di notorietà profetizzati da Andy Warhol, sprofondiamo adesso in un’epoca in cui shop virtuali, video e storie forgiano il più grande bazar della storia dove si vende di tutto: da articoli fatti a mano come magliette ricamate, a mobili restaurati, a sciarpe lavorate all’uncinetto, a qualunque oggetto di pessima qualità comprato direttamente online dalla Cina o negli sterminati pronto moda che punteggiano il nostro Paese. Uno su tutti? Il Macrolotto di Prato, diventato un pullulare di instagrammer. Il ricarico è impressionante: una maglietta pagata 5 euro viene venduta dieci volte tanto. E spesso totalmente in nero.
È questa la nuova e difficilmente quantificabile economia parallela, esplosa con la pandemia e ora cresciuta al punto da sfuggire alle maglie della regolamentazione. Un mercato gigantesco che prospera in una zona grigia fondamentale: il confine sempre più labile tra l’hobby occasionale e l’attività d’impresa.
Quando l’hobby diventa evasione
La maggior parte dei micro-venditori – che si tratti della ragazza che crea ceramiche fatte a mano o dell’appassionato di vintage che svuota la soffitta – agisce senza partita Iva, convinta che la vendita sui social sia un’attività privata non tassabile. In realtà, la normativa fiscale italiana (art. 55 del Testo unico delle Imposte sui redditi) non fissa un limite di fatturato (il mito dei 5 mila euro è un equivoco relativo al lavoro autonomo), ma si basa su due criteri molto più sfumati: l’abitualità e l’organizzazione. Insomma: vendere il proprio cappotto usato è un atto occasionale, ma creare un account Instagram con “drop” settimanali di vestiti, usare sponsorizzazioni e gestire un flusso costante di ordini, costituisce un’attività commerciale a tutti gli effetti. È qui che l’hobby diventa impresa, e l’evasione, da inconsapevole, diventa strutturata.
Pagamenti nascosti nei DM
Per anni, questo commercio è rimasto “invisibile” grazie a un’architettura di pagamenti tanto semplice quanto efficace. Le transazioni sui social avvengono spesso su un canale “nero”, direttamente nei messaggi privati (Dm), con pagamenti richiesti tramite metodi difficili da aggregare su larga scala, come la ricarica Postepay o l’opzione “Amici e parenti” di PayPal (che fa evitare commissioni e tracciatura). Accanto a questo, esiste il canale “grigio” delle piattaforme come Vinted o Etsy, dove il denaro confluisce in un portafogli (“wallet”) digitale, dando al venditore l’illusione che quei fondi, finché non vengono trasferiti sul conto corrente, restino in un limbo non monitorato.
DAC7: la fine dell’invisibilità
Ma l’era del Far West digitale sta (forse) volgendo al termine. La svolta sembrerebbe essere arrivata con la Direttiva DAC7, entrata in vigore in Ue nel gennaio 2023, che obbliga i gestori di tutte le piattaforme digitali (da Vinted a eBay, da Etsy ad Airbnb) a raccogliere, verificare e comunicare automaticamente alle agenzie fiscali nazionali i dati dei venditori che superano determinate soglie. La segnalazione all’Agenzia delle entrate scatta inesorabilmente al superamento di 30 transazioni di vendita in un anno o al raggiungimento di 2 mila euro di ricavi. Così, milioni di micro-venditori italiani che pensavano di operare nell’anonimato sono ora presenti nei database del Fisco, completi di codice fiscale, Iban e totale incassato. Se quei redditi non compariranno nelle dichiarazioni, i controlli arriveranno (almeno sulla carta) in automatico.
L’occhio digitale della Guardia di Finanza
L’Agenzia delle entrate non è però l’unico attore. La Guardia di finanza da tempo si muove usando algoritmi e tecniche di Osint (Open source intelligence). Reparti specializzati, come il Nucleo speciale frodi tecnologiche, monitorano i social, profilano gli account palesemente commerciali e incrociano tutto (stile di vita esibito, frequenza delle vendite, recensioni dei clienti) con le banche dati fiscali. Quando un profilo che movimenta migliaia di euro al mese risulta nullatenente, l’indagine è una conseguenza quasi certa.
Influencer e creator nel mirino
Il primo fronte a essere stato colpito è stato, prevedibilmente, quello più esposto: gli influencer e i content creator. Qui, l’evasione riguarda tanto la vendita di prodotti, quanto la mancata dichiarazione dei compensi milionari ricevuti dalle aziende per le sponsorizzazioni o da potenziali followers. Emblematico quanto accade su OnlyFans: a Mad Joe (Madalina Ioana) è stata contestata un’evasione di 1,5 milioni di euro. Eclatante poi l’operazione della Guardia di finanza di Bologna, ribattezzata “Sconosciuti al Fisco”, che nel marzo 2024, ha portato nel mirino nomi “social” come Gianluca Vacchi e Luis Sal, Giulia Ottorini o Elena Bertoli, e ha permesso di recuperare complessivamente a tassazione oltre 11 milioni di euro.
Un fenomeno dilagante
Ma si tratta di una situazione decisamente diffusa. Un esempio? Il mese scorso a Cosenza un giovane creator con oltre un milione di follower è stato individuato per aver omesso di dichiarare oltre 200 mila euro in due anni, e poco prima a Cattolica un altro aveva “dimenticato” di dichiarare circa 300 mila euro. C’è poi chi usa le piattaforme per il commercio elettronico puro. L’anno scorso a Verona la Gdf ha smascherato un venditore che, fingendosi privato, aveva creato un business parallelo fra scarpe e abbigliamento con ricavi superiori ai 100 mila euro. A Prato invece un cittadino di origine cinese utilizzava Vinted come un vero e proprio negozio online, arrivando a vendere circa duemila articoli per un ricavo (a nero) di 40 mila euro.
E-commerce fantasma e maxi frodi
Ma non è tutto. A Napoli sono stati sequestrati quasi 6 milioni di euro a un’azienda, nota su TikTok come “Napolitano Store” di Angelo Napolitano, specializzata nella vendita di prodotti di elettronica: evadeva l’Iva e utilizzava fatture false. Mentre a Biella sono finiti nel mirino i “furbetti di eBay”, 15 venditori che agivano come vere e proprie imprese commerciali e avevano omesso di dichiarare ricavi per 1,5 milioni di euro.
Non si tratta ovviamente di un problema solo italiano. Gli Stati Uniti stanno vivendo un caos normativo simile con il tentativo dell’Irs (Internal revenue service: l’Agenzia delle entrate americana) di imporre il Modulo 1099-K per chiunque riceva pagamenti superiori ai 600 dollari su piattaforme come Venmo o PayPal, mentre il Regno Unito ha adottato regole speculari alla DAC7 e la Francia ha implementato obblighi simili.
Le nuove tecniche per sfuggire ai controlli
Di certo è interessante analizzare come le strategie dei venditori abusivi siano in continuo aggiornamento. La prima regola è quella di far sparire le prove della transazione e così, dopo un primo contatto su piattaforma, si preferisce continuare la conversazione su WhatsApp o Telegram (più difficilmente controllabili) chiedendo pagamenti su carte-conto o servizi di digital banking. Il denaro incassato non viene così trasferito sul conto corrente tradizionale, ma accreditato su strumenti “satellite” come Revolut, N26 o altre prepagate dove il profitto viene speso direttamente, spezzando di fatto la catena che l’Agenzia delle entrate potrebbe seguire.
Per chi non vuole rinunciare alla visibilità della piattaforma, subentra la frammentazione degli account (con l’uso di prestanome o parenti, spesso ignari).
Il dropshipping mascherato
Fra tutte le strategie merita una menzione l’impresa fantasma per eccellenza: il cosiddetto dropshipping mascherato. Molti venditori, specialmente su Instagram e Facebook, non possiedono nemmeno la merce che espongono. Pubblicano foto accattivanti di gadget o vestiti e, una volta ricevuto il pagamento, ordinano semplicemente l’articolo da un fornitore a bassissimo costo, come Temu o AliExpress, facendolo spedire direttamente al cliente. Il venditore non ha magazzino, non gestisce spedizioni e incassa la differenza di prezzo come profitto netto completamente invisibile. Almeno per ora.