“Sul latino comica e ignorante polarizzazione. È la lingua della civiltà europea, estranea a qualsiasi forma di esclusivismo”
- Postato il 20 settembre 2025
- Società
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
Da brocardi e locuzioni sbandierate dai ministri in Aula alle parole usate nei dialoghi quotidiani: il latino, oggetto di contesa per il suo rientro nei programmi scolastici, ancora riveste un un ruolo cruciale per capire a fondo l’italiano e l’identità culturale europea. Ad analizzarne l’uso, la diffusione e la sua attualità è Francesco Lepore nel suo ultimo libro “Bellezza antica e sempre nuova. Il latino nel mondo di oggi” (Castelvecchi editore). Perché “di questa lingua”, scrive il giornalista e scrittore, “madre certissima dell’italiano, ce ne facciamo molto di più di quel che si pensi”. Lingua di oltre duemila anni di civiltà, ha plasmato la nostra idea di persona, collettività, diritto. Ma il latino è anche una chiave sorprendente per leggere il presente. Nel testo, che si presenta con la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, si racconta di come la lingua antica continui a parlarci e affascinarci. Seguono cinquanta brevi articoli – le commentatiunculae – tratti dalla rubrica quotidiana “O tempora, o mores” che l’autore cura in latino sul giornale online Linkiesta. Cronache attualissime, da Trump a Sanremo, da Bolsonaro agli Europei, raccontate con testo a fronte in un latino che vuole ancora essere accessibile e raccontare il nostro mondo. Ilfattoquotidiano.it pubblica la prefazione di Zuppi e un estratto del volume.
***
Prefazione di Matteo Maria Zuppi
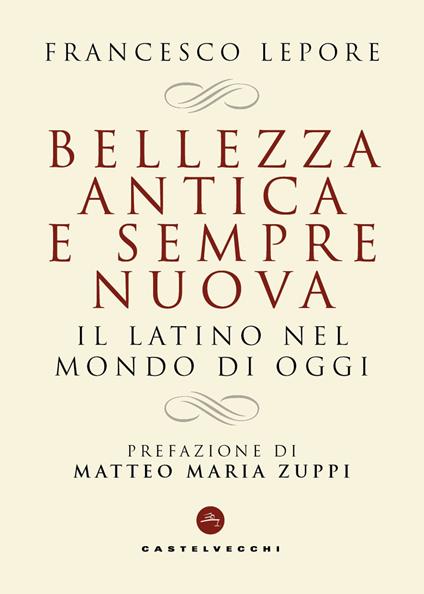 Mai come nel 2025 il latino è tornato al centro del dibattito pubblico dopo la annunciata reintroduzione di una tale materia nelle scuole secondarie di primo grado. Faccio parte della generazione che l’ha iniziato a studiare già alle medie, prima, dunque, che vi fosse abolito nel 1977, allenato peraltro da una mamma professoressa di latino che aveva lasciato la cattedra per dedicarsi all’aula dei figli! Ha messo in guardia l’ex rettore dell’Università di Bologna Ivano Dionigi a farne «una bandierina identitaria» o «una questione ideologica». Ed è quanto spiega Francesco Lepore in questo libro sul latino nel mondo di oggi. Nella prima parte dell’opera l’autore, che deve al papà, allievo di Francesco Arnaldi, l’amore per la lingua di Roma antica, sgombra infatti il campo da ogni equivoco. Nella temibile, a volte comica, certamente ignorante polarizzazione generalizzata, il latino non è appannaggio di nessuno. È ricchezza e bene comune, il mezzo per conoscere meglio l’italiano e le altre lingue europee, lingua di duemila anni della civiltà europea. Nel suo insieme, e per ciò stesso non solo quello classico, il latino ha infatti avuto un ruolo fondante nella costruzione dell’identità dell’Europa.
Mai come nel 2025 il latino è tornato al centro del dibattito pubblico dopo la annunciata reintroduzione di una tale materia nelle scuole secondarie di primo grado. Faccio parte della generazione che l’ha iniziato a studiare già alle medie, prima, dunque, che vi fosse abolito nel 1977, allenato peraltro da una mamma professoressa di latino che aveva lasciato la cattedra per dedicarsi all’aula dei figli! Ha messo in guardia l’ex rettore dell’Università di Bologna Ivano Dionigi a farne «una bandierina identitaria» o «una questione ideologica». Ed è quanto spiega Francesco Lepore in questo libro sul latino nel mondo di oggi. Nella prima parte dell’opera l’autore, che deve al papà, allievo di Francesco Arnaldi, l’amore per la lingua di Roma antica, sgombra infatti il campo da ogni equivoco. Nella temibile, a volte comica, certamente ignorante polarizzazione generalizzata, il latino non è appannaggio di nessuno. È ricchezza e bene comune, il mezzo per conoscere meglio l’italiano e le altre lingue europee, lingua di duemila anni della civiltà europea. Nel suo insieme, e per ciò stesso non solo quello classico, il latino ha infatti avuto un ruolo fondante nella costruzione dell’identità dell’Europa.
Identità, che, come scrive Lepore, «null’altro è se non la consapevolezza di ciò che siamo e, conseguentemente, il presupposto necessario per l’apertura alle altre culture e il dialogo con le stesse. […] In quest’ottica il riconoscimento del latino come lingua della civiltà europea per antonomasia sarà sempre estraneo a qualsivoglia forma di esclusivismo e amnesia culturale. Al contrario, porterà a non dimenticare e, perciò, a rettamente valorizzare i restanti apporti, a partire da quelli del greco, dell’ebraico biblico, dell’arabo».
Ma il latino è e resta anche la lingua ufficiale della Chiesa, come hanno ribadito esplicitamente e a più riprese i Papi dopo il Concilio Vaticano II. Francesco Lepore affronta l’argomento in uno specifico paragrafo dal titolo provocatorio Chiesa e latino: una storia d’amore finita?, osservando anche come le cicliche affermazioni dei media sulla presunta abolizione dell’uso del latino nella liturgia siano alimentate «dall’erronea e grossolana identificazione tra lingua e antica forma del rito romano». Né manca di sottolineare l’importante contributo degli scriptores della Sezione Latina della Segreteria di Stato all’attualizzazione del latino attraverso neologismi o ulteriori accezioni di termini antichi per esprimere concetti e realtà contemporanee.
Si può perciò dire che il latino è più vivo che mai: lo dimostrano, d’altra parte, i vari notiziari radiofonici, riviste e siti online in tale lingua. Lo dimostra lo stesso Lepore, che dal 2020 cura su «Linkiesta» la rubrica quotidiana O tempora, o mores, commentando un fatto del giorno in latino. Da essa sono tratti i cinquanta articoli brevi o commentatiunculae, che, suddivisi per anni e pubblicati con testo italiano a fronte, costituiscono la seconda parte di questo libro.
Immergendosi nelle quasi duecento pagine del volume, si potrà fare esperienza della forza seducente del latino, lingua – come suggerisce il titolo ispirato e adattato a uno dei più celebri passi delle Confessioni di Agostino – dalla «bellezza antica e sempre nuova». Il motto dell’Unione non a caso è proprio latino e ne adombra l’utilità: In varietate concordia.
***
Tertium non datur
Soprattutto inteso come «lingua di duemila anni di civiltà europea», il latino è pertanto più utile che mai. Ecco perché è da salutare positivamente la reintroduzione del latino alle medie (per essere precisi, a livello opzionale e negli ultimi due anni di quella che è ufficialmente denominata scuola secondaria di primo grado), annunciata il 15 gennaio 2025 dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Così ne parlava allora a «Il Giornale» lo stesso titolare del dicastero di viale Trastevere, dando per la prima volta notizia delle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e primo ciclo d’istruzione: «Apriamo le porte a un vasto patrimonio di civiltà e tradizioni; poi rafforziamo la consapevolezza della relazione che lega la lingua italiana a quella latina. E poi c’è il tema, importantissimo, dell’eredità» condivisa fra le diverse culture europee. Ragioni tutte, che sono state diffusamente illustrate nella bozza di documento delle Nuove Indicazioni Nazionali, da cui si è anche appreso che tale insegnamento si chiamerà “Latino per l’educazione linguistica” o, in acronimo, LEL.
In una successiva intervista, rilasciata al «Corriere della Sera» il 12 marzo, Valditara è tornato a parlare della questione. Chiarendo che «il latino diventa curriculare, ma opzionale», con «un’ora alla settimana in più» – a differenza, dunque, di quanto accaduto finora con un insegnamento di tipo extracurriculare, già previsto, in nome dell’autonomia scolastica, nei programmi di alcuni istituti secondari di primo grado –, ne ha spiegato l’importanza, indicando «quattro motivi: è una palestra di logica e abitua al ragionamento; come diceva Gramsci, abitua a studiare; aiuta a capire la grammatica e la sintassi italiana e a esprimersi meglio; è la testimonianza di una civiltà che ha condizionato la civiltà occidentale, la nostra».
Appare però necessario fare almeno alcuni distinguo e precisazioni relativamente alle due prime ragioni addotte dal ministro. Partiamo dall’affermazione su Gramsci, giustamente tirato in ballo anche da Luciano Canfora per liquidare come «stupidaggine» le reazioni di esponenti delle sinistre, alcune, invero, sguaiate e parossistiche, all’annunciata reintroduzione del latino perché «di destra»: il solo affermarlo significa, secondo l’illustre filologo classico, «non capire niente». Orbene, Gramsci riteneva sì altamente formativo il latino, che – così scriveva nel 1932 – «si studia per abituare i fanciulli a studiare in un determinato modo». Ma in pari tempo ne sottolineava pure, come ultimamente osservato da Guido Milanese, il carattere «strumentale rispetto alla formazione dello studente; e, come tutti gli strumenti», lo giudicava, «in prospettiva, ovviamente sostituibile». Anche se, sempre secondo Gramsci, un’eventuale sostituzione del latino risulterebbe comunque molto difficoltosa: «Non sarà agevole – così infatti il filosofo di Ales – disporre la nuova materia o la nuova serie di materie in un ordine didattico che dia risultati equivalenti di educazione e formazione generale della personalità, partendo dal fanciullo fino alla soglia della professionalità. In questo periodo infatti lo studio e la parte maggiore dello studio deve essere (o apparire ai discenti) disinteressato, non avere cioè scopi pratici immediati o troppo immediati, deve essere formativo, anche se “istruttivo”, cioè ricco di nozioni concrete». Circa poi l’argomento valditariano del latino “che insegna a ragionare”, argomento in realtà trito e ritrito, siamo di fronte alla prima delle «mitologie» sull’antico idioma. «Ciò è vero, e nello stesso tempo è del tutto banale», perché, volendo parafrasare le puntute critiche di Pierre Vesperini ad Andrea Marcolongo, anche la geometria e le lingue moderne abituano al ragionamento e a formarsi un pensiero.
C’è un ulteriore aspetto null’affatto convincente, anzi direi critico, del previsto insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado: il suo carattere opzionale. Lo ha detto a chiare lettere un nome dal calibro di Ivano Dionigi, che, ricordando come il latino non sia «né di destra né di sinistra», ha osservato: «Ci sono due modi per fare le cose: bene o meglio, un terzo non c’è. Se l’obiettivo è migliorare le competenze linguistiche dell’italiano, di cui il latino è mater certissima, perché reinserirne lo studio solo in via facoltativa dal secondo anno delle medie? Perché non per tutti? O è utile o no».
Salvo ripensamenti circa il carattere opzionale dell’insegnamento del LEL, le Nuove Indicazioni Nazionali sembrano fin troppo ricalcare, mutatis mutandis, la vecchia soluzione di compromesso – Concetto Marchesi era purtroppo già morto da cinque anni –, cui si era giunti con l’articolo 2 della legge 1859/1962 sulla cosiddetta “Riforma della Scuola media unica”. Proprio in quell’anno, rispondendo a un lettore di Vie Nuove, era intervenuto nel rovente dibattito sul latino alle medie anche Pier Paolo Pasolini, levando la sua voce originale e provocatoria in difesa di un tale insegnamento.
Eccone il testo integrale, che, pur se datato sotto alcuni rispetti, conserva appieno una prorompente forza di attualità: “Pur con molte incertezze, se io dovessi dare il mio voto sull’insegnamento del latino nelle medie, sarei per il sì. Sarei per il sì, ma evidentemente, in previsione di una riforma radicale della scuola. Perché, stando così le cose, il latino che si insegna a scuola è un’offesa alla tradizione. È il latino del perbenismo piccolo-borghese, accademico: criminale, insomma. Sotto tutta la televisione, atrocemente aleggiante, c’è, questo latino: piccolo, miserabile privilegio di cultura. Ma la colpa non è del latino. La colpa è della storia, che si insegna nelle scuole, o della letteratura, che si insegna nelle scuole, o della scienza, che si insegna nelle scuole. La nostra è una repubblica piccolo-borghese, la cui classe dirigente è in realtà, rispetto alla tradizione, a parole venerante, nei fatti sacrilega.
Guardi cos’ha fatto di Roma la speculazione edilizia, ossia la classe dirigente che sa il latino e che esalta il passato (un nobile romano recentemente ha dichiarato: io non leggo gli autori moderni, io leggo Dante!). E guardi cosa sta facendo nel Nord Italia il neo- capitalismo: una modernizzazione che rende irriconoscibili e mostruose le forme classiche di vita, senza dare nulla di nuovo al posto di queste se non il benessere economico e la cultura di massa! Ora io sento un profondo senso d’ira contro l’azione sacrilega, nei confronti del passato, cioè della nostra storia, della classe dirigente tradizionalista e cinica. Difenderei il latino, con ira, contro la sua difesa bugiarda. Dobbiamo conoscere e amare il nostro passato, contro la ferocia speculativa del nuovo capitalismo, che non ama nulla, non rispetta nulla, non conosce nulla.
Il povero latino delle medie è un primo, minimo mezzo di conoscenza di quella nostra storia che la ferocia capitalista cerca di mistificare, facendola sua. È perciò, secondo me, un errore voler abolire l’insegnamento del latino: un errore come ogni tattica. Lo scacchiere della lotta è immenso e complesso: il latino è solo apparentemente un’arma del nemico…”.
L'articolo “Sul latino comica e ignorante polarizzazione. È la lingua della civiltà europea, estranea a qualsiasi forma di esclusivismo” proviene da Il Fatto Quotidiano.



