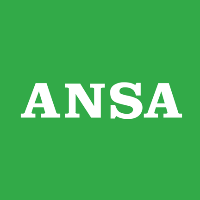Pensioni, la grande svalutazione: 13.000 euro persi in dieci anni dai trattamenti medi
- Postato il 17 settembre 2025
- Di Panorama
- 5 Visualizzazioni


Una perdita nei prossimi dieci anni di oltre 13.000 euro per le pensioni superiori a 2.500 euro lordi (meno di 2.000 netti). E addirittura tagli intorno ai 115.000 euro per chi percepisce oltre 10.000 euro lordi mensili (circa 6.000 netti). Sono i risultati, secondo le stime calcolate dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, delle continue manovre sui trattamenti pensionistici varate negli anni passati. Lo studio congiunto di Itinerari Previdenziali e CIDA (Confederazione dei dirigenti e quadri pubblici e privati), presentato a Roma in occasione della conferenza stampa di lancio dell’Osservatorio sulla spesa pubblica “La svalutazione delle pensioni in Italia”, fotografa una situazione drammatica..
Nell’arco di trent’anni, sottolineano i ricercatori, le pensioni medio-alte hanno progressivamente perso oltre un quarto del loro potere d’acquisto. Una pensione da 10mila euro lordi mensili, ad esempio, ha lasciato sul terreno quasi 180mila euro: l’equivalente di un anno intero di assegno. Un drenaggio silenzioso, ma devastante.
“Il sistema punisce chi ha contribuito di più e mortifica chi ha versato regolarmente imposte e contributi per decenni – ha affermato Stefano Cuzzilla, presidente di CIDA –. Le pensioni non sono regali, ma salario differito, il frutto di una vita fatta di lavoro e sacrifici. Rappresentano anche il più grande patto intergenerazionale che un Paese possa stringere: chi lavora oggi sostiene chi ha lavorato ieri, con la certezza di essere domani a sua volta sostenuto. Ma senza regole stabili e senza fiducia, il patto rischia di dissolversi”.
La perequazione italiana, un unicum in Europa
Il cuore del problema si chiama perequazione automatica, il meccanismo che dovrebbe garantire la rivalutazione delle pensioni all’andamento dei prezzi o, in alcuni sistemi, anche dei salari. In teoria, si tratta di uno strumento di equità intergenerazionale, adottato in tutti i principali Paesi europei. In pratica, in Italia questo meccanismo è stato oggetto di interventi legislativi discontinui e contraddittori, che lo hanno trasformato in uno strumento di riduzione permanente delle prestazioni.
Se in alcuni periodi le pensioni sono rimaste addirittura prive di rivalutazione, in altri hanno ricevuto indicizzazioni parziali o calcolate con criteri nuovi a seconda delle manovre finanziarie, spesso con il risultato finale di erodere progressivamente il reddito dei pensionati con assegni medi e alti. In questo senso l’Italia rappresenta, in negativo, una vera e propria eccezione tra i Paesi OCSE.
Il biennio 2023-2024: l’effetto combinato di inflazione e tagli
Il 2022 sembrava aprire a un ritorno di equilibrio grazie al ripristino dello schema originario del 1996: rivalutazione piena dell’inflazione fino a quattro volte il minimo INPS, parziale (90%) fra quattro e cinque volte, ulteriormente ridotta al 75% oltre questa soglia. Un meccanismo a scaglioni che, per quanto imperfetto, garantiva una distribuzione più equa.
Con la manovra del governo Meloni, invece, il quadro si è nuovamente ribaltato. Per gli anni 2023 e 2024 si è deciso di garantire la rivalutazione completa alle pensioni minime e sociali, peggiorando però significativamente quella delle rendite superiori a cinque volte il trattamento minimo. L’aspetto più controverso è stato l’applicare la riduzione non soltanto alle quote eccedenti le soglie, ma all’intero importo: così, ad esempio, nel 2023 un pensionato con 3.000 euro lordi mensili ha ricevuto un adeguamento del 4,3% a fronte di un’inflazione reale superiore all’8%. La conseguenza: una perdita immediata e strutturale, destinata a protrarsi negli anni a venire. Solo a partire dal 2025, con l’attenuarsi delle tensioni inflazionistiche, si è tornati a un meccanismo a tre fasce: 100% fino a quattro volte il minimo, 90% tra quattro e cinque volte, 75% oltre. Ma i danni accumulati nel biennio precedente non vengono recuperati.
Due cifre che parlano da sole
La pubblicazione presentata da Itinerari Previdenziali mette nero su bianco il conto: tra il 2012 e il 2025 una pensione da 10mila euro lordi ha perso circa 178mila euro, mentre un assegno da 5.500 euro ne ha lasciati sul campo 96mila. E la sottrazione non riguarda soltanto le grandi cifre della dirigenza pubblica e privata. Secondo Brambilla, curatore dello studio, il cosiddetto “ceto medio” dei pensionati è quello che soffrirà di più, perché a fronte del grosso dei 56 miliardi di IRPEF che ogni anno provengono dai redditi da pensione, vedrà evaporare ulteriori 45 miliardi nei prossimi anni a causa delle rivalutazioni limitate.
Equità rovesciata e il nodo dell’evasione
“È un vero ribaltamento del principio di equità – ha spiegato Cuzzilla –. Quasi 1,8 milioni di pensionati con redditi superiori ai 35mila euro lordi annui, pur rappresentando meno del 14% del totale, garantiscono da soli il 46,3% del gettito IRPEF della categoria. Eppure sono loro i più penalizzati. Al contrario, chi ha versato pochi o nessun contributo è stato tutelato dall’inflazione grazie a rivalutazioni piene”.
Un meccanismo che rischia di alimentare divisioni sociali, tanto più se confrontato con i circa 90 miliardi che ogni anno sfuggono al fisco: una voragine di evasione che rende ancora più insopportabile la concentrazione dello sforzo fiscale sempre sulle stesse spalle.
Corte Costituzionale e legittimità: un dibattito aperto
Non stupisce che negli ultimi quindici anni la Corte Costituzionale sia stata più volte sollecitata a pronunciarsi sulla legittimità delle mancate rivalutazioni. L’ultima sentenza, la n. 19 del 2025, ha dichiarato conforme alla Carta il meccanismo di riduzione introdotto nella Legge di Bilancio 2023. Un pronunciamento coerente con le decisioni assunte negli ultimi undici anni, ma non immune da critiche: la stessa Corte, in precedenti pareri, aveva raccomandato che i tagli fossero proporzionati, temporanei e non ripetuti. Tre principi che, secondo osservatori ed esperti, sembrano ormai sistematicamente disattesi. La conseguenza, avvertono, è duplice: da un lato lo Stato ottiene un risparmio immediato, dall’altro mina la fiducia dei giovani lavoratori, già esposti a precarietà occupazionale, nel sistema previdenziale stesso. Se i versamenti contributivi non garantiscono un adeguato importo futuro, perché mai dovrebbero sentirsi motivati a rispettare le regole?
Serve un cambio di rotta
Il messaggio lanciato da Cuzzilla e Brambilla è chiaro: la prossima Legge di Bilancio deve diventare un’occasione di giustizia sociale, ristabilendo regole stabili e certe. Occorre riportare la perequazione ai livelli previsti negli altri Paesi europei, smettendo di usarla come leva contabile per fare cassa. “La fiducia nel sistema pensionistico si regge su due pilastri: certezza del diritto e stabilità delle regole – ha concluso Cuzzilla –. Colpire chi ha versato quarant’anni di contributi significa spezzare il patto sociale e generazionale che tiene insieme il Paese. Recuperare equilibrio sarà difficile, ma non impossibile: occorre una scelta politica coraggiosa e una magistratura costituzionale pronta ad affrontare nel merito le storture di un sistema che, così com’è, rischia di crollare”.