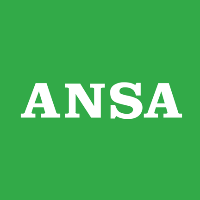L’artista che ha scolpito la Sardegna
- Postato il 27 settembre 2025
- Di Panorama
- 4 Visualizzazioni


Chi non conosce Francesco Ciusa (Nuoro 1883 – Cagliari 1949), a cui lo Spazio Ilisso di Nuoro dedica la maggiore mostra monografica mai prima allestita (a cura di Elena Pontiggia, fino al prossimo 5 aprile), troppo poco sa della scultura italiana del Novecento. Dopo studi specifici a Firenze dove apprezza soprattutto lo scultore d’origine siciliana Domenico Trentacoste, Ciusa torna ben presto nella sua isola da dove non se ne sarebbe più andato, anche se muovendosi prevalentemente fra Sardegne diverse da quella natale: la Nuoro di Grazia Deledda, dell’amico poeta Sebastiano Satta e del pittore Antonio Ballero, pioniere del folclorismo modernista che impronta la migliore pittura sarda di inizio secolo.
A Sassari fa coppia con Giuseppe Biasi, il maggiore dei folcloristi, con cui peraltro trova poca sintonia artistica. Pur avvertendo, come lui, la suggestione del modernismo nordeuropeo, Ciusa evita qualunque tentazione pittoricista preferendo orientarsi su un realismo robusto e composto, contrapponibile al verismo più commerciale di Vincenzo Gemito, che viene sollecitato dalla diffusione internazionale del credo socialista. Con Biasi condivide semmai la centralità della cultura tradizionale sarda, celebrata nella sua impareggiabile originalità, rispetto alla quale la modernità artistica non è un fine, ma un mezzo.
Di ritorno a Nuoro, Ciusa crea l’opera per la quale fu più conosciuto, grazie all’enorme successo che consegue alla Biennale di Venezia del 1907: la Madre dell’ucciso, ricordo di un episodio locale di banditismo, a suo modo rodiniana nel partire dalla figura avviluppata del Pensatore. Scrissi così della Madre, di cui si sarebbero viste volentieri, insieme al gesso veneziano, anche le conseguenti versioni in bronzo (Roma, GNAMC) e marmo (Pettinengo, Museo delle Migrazioni): «La donna, in costume tradizionale a più strati, viene rappresentata seduta per terra e chiusa a riccio, i piedi nudi accostati e le braccia a stringere le gambe sotto le ginocchia, nella posizione in cui le donne barbaricine erano solite vegliare le salme prima di cominciare i lamenti.
La si potrebbe racchiudere in un uovo, se la testa, avvolta da un velo sporgente sul davanti che lascia libero solo il centro del volto, non si ergesse alta e ancora fiera, malgrado l’annichilimento per il dolore provato sia così totale da non lasciare spazio a null’altro che a un’impassibilità glaciale. Ha buon gioco, Ciusa, nello sfruttare l’ombra del velo per attraversare le rugosità del viso come un paesaggio della sofferenza, trattenendo nei solchi epidermici sui quali si intrufola la luce tutta la tensione che la donna, a riprova della sua estrema, ammirevole dignità, introietta invece di scatenare platealmente. Il resto è silenzio, direbbe Shakespeare, profondissimo, in cui comunque, per dirla invece come Ciusa, “splendeva l’isola in notte tanto nera”». Ne Il pane (1907), una spigolatrice di Millet lavora la pasta sopra un desco, sdraiata e a piedi nudi.
Si respira un’aria finanche classicista nella concentrata austerità di questa massaia che nulla concede al sentimento, pretendendo semmai un rispetto che deve partire da quei piedi avanzati con cui si rammenta ai borghesi che i popolani si permettevano di usare le scarpe solo in occasioni speciali.
Ma il realismo sta troppo stretto a Ciusa, che dopo il ritorno dalla Grande Guerra si trasferisce a Cagliari dove conduce una produzione di ceramiche di ispirazione locale (S.P.I.C.A.). Intanto la gravità morale delle prime opere cominciava a diluirsi in un’aspirazione spirituale che dalla forma, che pure preserva la sua tipica compattezza costitutiva, intende cavare l’intuizione del simbolo rivelatore, valevole oltre la contingenza dell’immediato, reinventando la sardità secondo caratteri in cui l’essenza prevale sul semplice riscontro esteriore.
Il ritorno (1922), in cui l’aneddoto isolano è ormai sublimato, introduce un tema formale che accomuna Ciusa al faentino Domenico Rambelli, altro scultore sui generis dell’epoca: la figura ammantata, col vestiario, metafora della michelangiolesca, ma anche rodiniana onnipotenza della materia da cui solo lo spirito può emanciparsi, che riduce al minimo la visibilità del corpo umano. Esemplari in questo senso il bicromatico Sacco d’orbace (1922-23), con le impaurite teste di padre e figlioletto che emergono appena dal bigio di un blocco a siluro, e la toccante Campana (1922-23), opera a cui mi lega una confidenza speciale.
Si può dire che Ciusa si stia muovendo verso il Novecento sarfattiano, anche per via della sua adesione al fascismo? Vi fu in lui un qualche ritorno all’ordine, quando l’ordine non lo aveva mai perso? Forse no. A eccezione di certe teste infantili che devono, a Desiderio e Rossellino più che a Medardo Rosso, il suo senso della plasticità piena non si richiama a modelli della grande tradizione rinascimentale con cui rinverdire i fasti nazionali. Persiste semmai l’intento di personalizzare in una chiave di sardità universalizzata l’influsso internazionalista, come verrà dichiarato in maniera esplicita in Donna con levriero (1931), perfino erotica nel conformarsi al déco più alla moda.
Ma se non fosse per la spontanea renitenza nei confronti di espressionismi troppo caricati, si direbbe che lo spiritualismo di Ciusa, che si palesi in simbolismi ancora mimetici (l’intrigante Bacio, 1927; la trionfante Anfora, 1927-28) così come in planarità stilizzate alla primitiva, morbide e scorrevoli, che nulla possiedono di latino, etrusco o giottesco, quindi di conciliabile con la radice italica (La famiglia protetta, 1922-23; La vita, 1928-30; L’amore, Madonnina e Cristo deposto, 1931-32), non sia affatto distante da quello di Adolfo Wildt, artista la cui direzione intrapresa non poteva essere certo considerata di troppo riferimento per Novecento.
La singolarità di Ciusa è d’altra parte evidente anche nella monumentalistica, genere che a torto si potrebbe credere fuori dalle sue corde, in cui propone, senza nemmeno uscire dalla mostra (Iglesias, monumento ai Caduti, 1923-27), compenetrazioni tra naturalismo simbolista e secondo Futurismo di contorta, ma indubbia efficacia compositiva (Ali alla Patria, 1927). Che dire, poi, delle arti applicate di Ciusa oltre la già citata ceramica, la grafica, la formidabile mobilia in legno e in ferro? E la pittura (sorprendente la Cena dei morti, 1910, in un Sezessionstil vernacolare che sta anticipando Casorati)? Chi non le conosce, troppo poco sa di Ciusa.