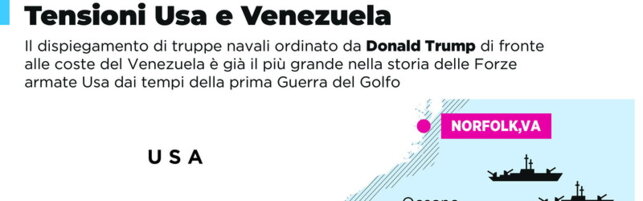La lezione di Cacciari in Biennale sulla filosofia della guerra
- Postato il 7 novembre 2025
- Di Il Foglio
- 1 Visualizzazioni

La lezione di Cacciari in Biennale sulla filosofia della guerra
La filosofia della guerra è madre d’ogni filosofia. E il suo custode, in tempo di guerra, è forse Massimo Cacciari. Il filosofo, già sindaco di Venezia, epigono di Eraclito. Studioso del Polemos che pure dice: “La guerra non esiste”. (Il paradosso, d’altronde, è l’impulso del pensiero).
La lezione "La morte dello Ius belli", introdotta ieri dal patriarca Francesco Moraglia e dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuco, nell’ambito dei progetti speciali dell’archivio storico, comincia così: “La guerra non esiste”. O perlomeno non esiste come monolite. Non esiste, né mai è esistita, come fenomeno unico o come fatto astratto. Per quanto tutte le guerre – tutte diverse – siano sempre figlie di Polemos. Che gli uni divide come schiavi, gli altri come liberi.
Ed ecco dunque la guerra come specchio dell’uomo. Non come accidente, non come parentesi. Bensì come condizione permanente ma proteiforme. Latente ma pronta a fiorire nei contorni del tempo. Ogni guerra porta con sé un pensiero. Ogni conflitto trasforma le regole del possibile. Dal fratricidio greco, dalla guerra di Troia, Cacciari ripercorre la storia degli eserciti fisici e metafisici. Delle armi che non si possono educare, ma che loro malgrado educano l’uomo al loro utilizzo e allo Ius belli. Il diritto della guerra che oggi, per il filosofo, è morituro.
La lezione di Cacciari, al cospetto della sala gremita da una Serenissima in ascolto, attinge ad Alberico Gentili e Napoleone. Al nemico da riconoscere come giusto, e alla guerra come liberazione. Si ritempra, ancora, in Immanuel Kant e nella sua “pace perpetua”. In un caleidoscopio di conflitti – mediati nel diritto – che il tempo presente sembra infrangere in una mancata distinzione tra città e campo, tra uomo e soldato.
Il confine tra nemico giusto e nemico assoluto dirada. Dalle guerre napoleoniche – in cui, pur nel massacro, resta la giustificazione della liberazione dei popoli – fino alle guerre mondiali, il nemico perde consistenza. Smette di essere Stato. Diventa incarnazione del male. La Prima guerra mondiale – “epifania dell’Anticristo” – segna il passo verso un conflitto in cui non esistono più margini di duello. In cui, nello scontro a due, l’uno non si riconosce più nel volto dell’altro. Il nemico è un criminale. La Seconda guerra mondiale esaspera l’irrazionale. E nei conflitti contemporanei – nel mondo sono oltre 50 – diventa criterio.
La filosofia della guerra – da Eraclito a Cacciari – non è perciò solo specchio delle cose, ma altresì monito delle idee. La guerra ritorna, oggi, come prova di civiltà benché la “libido pugnandi” si esprima senza filtri. E la ragione politica diventi persino insufficiente nel contenerla. La filosofia della guerra è filosofia della giustizia. E’ riconoscimento dell’altro come giusto hostis affinché la parola "pace", riprendendo Buttafuoco, non sia soltanto l'ultimo dei tabù. E per giunta il più stanco.
Continua a leggere...