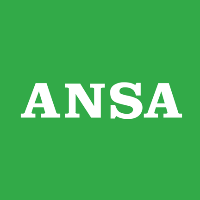Imputato Darwin, alzatevi. Storia del processo Scopes nel Tennessee degli anni Venti
- Postato il 6 ottobre 2025
- Di Il Foglio
- 1 Visualizzazioni

Imputato Darwin, alzatevi. Storia del processo Scopes nel Tennessee degli anni Venti
“Sono stato nelle loro città e ho visto gli altari sui quali sacrificano il futuro dei loro figli agli dèi della scienza. E quali sono le loro ricompense? Confusione e autodistruzione. Nuovi modi per uccidersi a vicenda in guerra. Vi dico, signori, la via della scienza è la via dell’oscurità”.
Così arringa la giuria uno dei protagonisti del film …e l’uomo creò Satana (Inherit the Wind, 1960). La pellicola ricostruisce il cosiddetto “Processo Scopes”, o “Processo della scimmia di Scopes”, un celebre caso del 1925 legato all’insegnamento scolastico della teoria dell’evoluzione. La vicenda ricevette enorme attenzione sui mezzi di informazione e rimase impressa nella memoria tanto da ispirare, oltre trent’anni dopo, una grande produzione hollywoodiana con Spencer Tracy e Gene Kelly. Ma quel processo passato alla storia fu, secondo il paleontologo e divulgatore scientifico Stephen Jay Gould, “il risultato di un accumulo di eventi improbabili”.
Tutto comincia a Dayton, quando i notabili locali decidono di mettere alla prova il Butler Act che proibisce di insegnare l’evoluzionismo a scuola
Tutto cominciò un pomeriggio del maggio 1925. L’insegnante di scuola superiore John Scopes, allora venticinquenne, stava giocando a tennis a Dayton, una cinquantina di chilometri a nord di Chattanooga, Tennessee. In teoria Scopes sarebbe già dovuto andare in vacanza con la famiglia alla fine della scuola, ma restava in città perché aveva un appuntamento qualche settimana dopo con una ragazza (“una bellissima bionda”). Un ragazzo si avvicinò per avvisarlo che era atteso all’emporio Robinson dal proprietario. Scopes finì con calma la partita e si avviò verso l’emporio. Qui trovò riuniti i notabili della piccola cittadina attorno a una bottiglia di Coca-Cola, vanto produttivo locale. Il tema della riunione era il Butler Act, una legge dello stato del Tennessee promossa da un agricoltore ed esponente politico, John Washington Butler. Butler faceva parte di una delle associazioni di cristiani fondamentalisti che continuavano a sostenere un’interpretazione letterale della Bibbia, respingendo ogni teoria o scoperta ritenuta in contraddizione. Una posizione che all’epoca, come sottolinea lo studioso David Masci, era già minoritaria anche negli ambienti religiosi, perlomeno in Europa. “Alla sua morte, nel 1882, Darwin era considerato il più grande scienziato della sua epoca […] Proprio la Chiesa che la sua teoria aveva sfidato gli concesse un funerale di Stato e la sepoltura nell’Abbazia di Westminster, vicino alla tomba di Sir Isaac Newton. L’idea di Darwin era ancora provocatoria, ma al momento della sua morte aveva ottenuto l’accettazione generale, anche tra molti membri del clero anglicano. Infatti, la sua sepoltura nell’abbazia fu vista da alcuni contemporanei come simbolo di una tregua instabile tra scienza e religione in Gran Bretagna”.
Lo stesso proponente della legge, in seguito, ammise che non sapeva nulla di evoluzione. “Avevo letto sul giornale che i ragazzi tornavano da scuola e dicevano ai loro genitori che la Bibbia era priva di senso”. Il 21 marzo fu così approvato il Butler Act, primo tassello improbabile di questa storia. La legge rendeva “illegale per ogni insegnante in ogni università e scuola pubblica insegnare qualunque teoria che neghi la storia della Creazione divina dell’uomo, così come dettata dalla Bibbia, e insegnare invece che l’uomo è disceso da un ordine animale inferiore”. L’opposizione nel Senato dello stato sottovalutò l’iniziativa, confidando nel veto del governatore anziché osteggiarla (come era invece avvenuto per un’iniziativa simile nel Kentucky). Il veto però non arrivò. Il governatore era convinto che la legge sarebbe rimasta inutilizzata, permettendogli di racimolare qualche consenso tra i rappresentanti delle aree rurali. Fin qui la cosa sembrava abbastanza innocua, e i fondamentalisti del Tennessee una combriccola folcloristica che ricorda i “nazisti dell’Illinois” citati da John Belushi nel film The Blues Brothers.
Ma è qui appunto che entra in campo il giovane (e fin qui ignaro) insegnante Scopes. Oltre a Robinson, gestore dell’emporio, quel pomeriggio Scopes si trovò davanti tra gli altri George Rappleyea, navigato manager di una grande società di carbone e acciaio. Fu quest’ultimo, secondo alcune testimonianze, a suggerire che lo sciagurato Butler Act rappresentasse una bella occasione di portare la piccola Dayton alla ribalta nazionale. Una comunità rurale e conservatrice, il rapporto tra scienza e religione, la libertà di espressione e di insegnamento: gli ingredienti per una miscela esplosiva c’erano già tutti. Tutto quello che serviva era un insegnante disposto a sfidare il divieto, e chi meglio di un giovane appena arrivato? Scopes non era peraltro neppure un docente di biologia. Era stato infatti assunto come allenatore per le attività atletiche e docente di fisica a 150 dollari al mese, ma si era trovato poi a fare supplenze anche di biologia. Durante queste supplenze non era neppur sicuro di aver effettivamente presentato agli studenti la teoria dell’evoluzione. Ma il libro di testo ne parlava; quindi, implicitamente la teoria era nel programma scolastico. Insomma, Scopes si fece convincere a fare “da vittima sacrificale”. Il costo della sua difesa fu assunto dall’American Civil Liberties Union.
Il giovane insegnante John Scopes convinto a fare da “vittima sacrificale”. Canzoni folk e una scimmia fotografata con una Coca-Cola
Reo confesso, Scopes fu effettivamente arrestato, ma mai incarcerato. Per l’accusa e per la difesa, a questo punto, servivano pezzi da novanta. A perorare l’accusa si chiamò William Jennings Bryan, formidabile oratore, fervente proibizionista, tre volte candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il Partito democratico. Ormai avviato al declino tanto da essere soprannominato “the tinpot Pope of the Coca-Cola belt” (“il Papa in lattina della terra della Coca-Cola”), forse Bryan vide nel processo un’ultima occasione di gloria. Per la difesa, Rappleyea provò addirittura a contattare lo scrittore e pioniere della fantascienza britannico H. G. Wells. Questi rispose saggiamente che non aveva le competenze legali per difendere chicchessia, tantomeno negli Stati Uniti. Entrò allora in campo l’avvocato Clarence Darrow, noto per le sue battaglie per i diritti dei lavoratori e per una memorabile arringa di ben otto ore nel corso del processo per il “crimine del secolo”, il “caso Leopold and Loeb” in cui due studenti dell’Università di Chicago erano accusati di aver rapito e ucciso un minorenne al solo scopo di dimostrare la propria superiorità intellettuale commettendo “il delitto perfetto”.
Di lì in poi iniziò quello che oggi si definirebbe “un circo mediatico”, e a maggior ragione dato che al seguito folcloristico furono aggregate perfino scimmie ammaestrate tra cui quella nota come Joe Mendi, già celebre per la sua partecipazione a film e spettacoli di vaudeville. Durante il processo, la scimmia fu vestita di tutto punto e fotografata con in mano un bicchiere di Coca-Cola (what else?) nel solito negozio di Robinson. Il processo Scopes divenne rapidamente noto come “il processo delle scimmie” (“Scopes Monkey Trial”). Migliaia di persone e centinaia di cronisti, accampati su brandine improvvisate, affollarono Dayton. Fu anche uno dei primi processi ad essere trasmesso alla radio, ispirando perfino canzoni folk come “You Can’t Make a Monkey Out of Me,” o “Monkey Business Down in Tennessee”.
“Then to Dayton came a man / With his ideas new and grand / And they said we came from monkeys long ago. / But in teaching his belief / Mr. Scopes found only grief / For they would not let their old religion go”.
“E a Dayton venne un uomo / Con idee nuove e ambiziose / E disse che siamo venuti dalle scimmie tanto tempo fa / Ma insegnando la sua convinzione / Trovò solo guai / Perché non volevano abbandonare la loro vecchia religione”.
Il processo si svolse in un caldo torrido che costrinse a tenere i dibattimenti (introdotti sempre da una preghiera) all’aperto. L’arcigno accusatore di Scopes, Bryan, “si presentava in maniche di camicia e bretelle e si rinfrescava con un ventaglio di foglie di palma” secondo una cronaca dell’epoca; il difensore Darrow “anche lui in maniche di camicia, indossava bretelle viola”.
La difesa inizialmente intendeva puntare sul fatto che il Butler Act violava la libertà di insegnamento ed era quindi incostituzionale. Ma l’avvocato Darrow decise di cambiare strategia e puntare invece a dimostrare che non c’era effettivamente contraddizione tra quello che era scritto nella Bibbia e la teoria dell’evoluzione. Così chiamò a testimoniare una serie di esperti, perlopiù scienziati di provata fede cristiana. Il giudice ne volle ascoltare solo uno; il punto non era tanto la verità scientifica della teoria dell’evoluzione, ma il fatto che era proibita dalla legge, punto e basta. Dagli altri esperti accettò solo testimonianze scritte che furono ampiamente riprese dalla stampa quotidiana. Bryan, con la sua caratteristica retorica roboante, entrò invece nel merito, mettendo in dubbio perfino che gli esseri umani fossero mammiferi e agganciandosi velenosamente al curriculum di Darrow. Non erano proprio casi come quelli degli studenti omicidi Leopold e Loeb a dimostrare che “troppa conoscenza è pericolosa”?
Verso la fine del processo, Darrow si giocò una carta a sorpresa. Poiché il giudice non ammetteva esperti dal mondo della scienza, chiese di poter interrogare lo stesso Bryan come esperto della Bibbia. Qui Bryan cadde più volte in confusione e contraddizione ammettendo, ad esempio, che forse i giorni della creazione descritti nel Libro della Genesi non fossero esattamente di ventiquattr’ore. Fu soprattutto quest’ultima fase del processo, ampiamente rielaborata anche nel film, a contribuire all’immagine del processo come un trionfo contro l’oscurantismo.
Le contraddizioni dell’accusa, il verdetto viziato da un errore procedurale, quel 17 per cento di creazionisti in America oggi
L’insegnante Scopes fu effettivamente condannato dal giudice ad un’ammenda di cento dollari. Ma l’unico appiglio che permise di ribaltare la sentenza fu un cavillo formale: ogni ammenda superiore ai cinquanta dollari doveva essere deliberata dalla giuria nel suo complesso e non solo dal giudice. Il già citato Stephen Jay Gould, nella sua ricostruzione, smonta una diffusa mitologia del processo secondo cui Scopes fu incriminato (come si è visto, fu convinto ad autodenunciarsi rispetto ad una legge che nessuno pensava sarebbe mai stata applicata) e il processo segnò una decisa sconfitta dei movimenti anti-evoluzionismo. Il Butler Act rimase in vigore addirittura fino al 1967. Pochi anni dopo, nel 1973 il Senato del Tennessee approvò un “Genesis Bill” che prescriveva di riservare eguale spazio all’insegnamento dell’evoluzione e della creazione, raccomandando altresì che l’evoluzione “non fosse rappresentata come un fatto scientifico”. Gould notava anche la persistenza di movimenti anti-evoluzione nella società americana. Attualmente, secondo il Pew Research Center, una delle fonti di dati più accreditate per gli studi sulla percezione pubblica, attualmente circa l’80 per cento dei cittadini americani considera vera la teoria dell’evoluzione, mentre il 17 per cento ritiene che “gli esseri umani siano esistiti nella forma attuale fin dagli inizi del tempo”.
Bryan non poté fare in aula il suo discorso finale, che distribuì però ai giornalisti. “La scienza è una forza magnifica, ma non è un’insegnante di morale” scrisse. “Può perfezionare le macchine, ma non aggiunge vincoli morali per proteggere la società dall’uso improprio delle macchine”. Duramente provato dal processo, morì improvvisamente cinque giorni dopo la sua conclusione.
Che ne fu di John Scopes? Non tornò mai più a insegnare a scuola. Studiò geologia all’Università di Chicago e lavorò per l’industria petrolifera. Il caos del processo probabilmente gli fece saltare l’appuntamento con la ragazza bionda di Dayton che sperava di incontrare. Nel 1930 si sposò a Maracaibo con Mildred Walker, con cui ebbe due figli. Non sfruttò in alcun modo la popolarità ottenuta grazie al processo, vivendo il resto della vita lontano dai riflettori, fino alla morte avvenuta in Louisiana nel 1970.