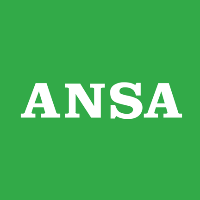Frankenstein è italiano: ecco come nacque l’opera di Mary Shelley che ha rivoluzionato la letteratura
- Postato il 11 novembre 2025
- Di Panorama
- 2 Visualizzazioni


Chi ha partorito “Frankenstein”, l’opera letteraria che ha dato il via al genere della fantascienza? Da dove nasce l’idea di uno dei mostri più famosi della letteratura mondiale? Da Mary Shelley, direte tutti. E avete ragione, l’idea originale e brillante dello scienziato che vuole superare i limiti umani e della creazione che sfugge al suo controllo, ha preso certamente vita dalla penna di quella geniale scrittrice diciannovenne. Eppure, vi sorprenderà probabilmente sapere che la fonte di ispirazione per il personaggio di Viktor Frankenstein è prettamente italiana. Deriva infatti da un medico bolognese che appendeva delle rane morte nel suo giardino, per verificare la reazione dei loro muscoli all’elettricità dei fulmini.
Nel frattempo, il 7 novembre, è uscito su Netflix il nuovo film «Frankenstein» di Guillermo del Toro, e la National Library of Scotland sembra pronta a svelare documenti inediti su Mary Shelley. Se vi abbiamo incuriosito (come speriamo), soddisferemo questa vostra curiosità approfondendo la genesi del romanzo.
La notte che cambiò la letteratura
Siamo a Villa Diodati, sul lago di Ginevra, nel giugno del 1816. «Era una notte buia e tempestosa», come comincerebbero tutti i romanzi horror che si rispettino. Ma in questo caso non è un modo di dire: fuori infuriava davvero la tempesta, una di quelle infinite che segnarono «l’anno senza estate», quando il vulcano Tambora aveva oscurato i cieli del mondo. E forse fu anche quella tempesta a ispirare il romanzo. Fatto sta che dentro la villa, un gruppo di giovani intellettuali aveva lanciato una sfida: scrivere l’opera più terrificante ispirata all’aldilà.
Mary Wollstonecraft Godwin – che di lì a poco sarebbe diventata Mary Shelley – aveva appena diciannove anni. Attorno a lei, il marito poeta Percy Bysshe Shelley, il celebre Lord Byron, la sorellastra Claire Clairmont e il medico John Polidori. Nessuno di loro poteva immaginare che quella scommessa avrebbe generato non solo il capolavoro del gotico, ma addirittura il primo romanzo di fantascienza della storia, che avrebbe avuto un’enorme influenza sulle generazioni successive.
L’ombra italiana dietro la creatura
E qui arriviamo al punto clou: da dove viene davvero la scintilla che animò la creatura? Non fu un’invenzione dal nulla, no. Nel suo romanzo c’è tutta la scienza del tempo, quell’illuminismo vorticoso che stava rivoluzionando l’Europa. E al centro di quella rivoluzione scientifica c’era un italiano: Luigi Galvani.
Il medico bolognese aveva scoperto qualcosa di prodigioso. Appendendo rane morte nel suo giardino durante i temporali, aveva osservato che i loro muscoli si contraevano quando venivano colpiti dai fulmini. L’elettricità poteva dare – o restituire – il movimento ai corpi inermi. Poteva, forse, ridare la vita ai morti.
Il nipote di Galvani, Giovanni Aldini, aveva portato quegli esperimenti ancora più in là, in direzioni che oggi farebbero rabbrividire. E Mary Shelley conosceva quegli esperimenti. Li aveva studiati, se n’era nutrita, li aveva trasformati in letteratura.
Quando il dito si mosse
Nel romanzo c’è una scena che ricorda effettivamente da vicino gli esperimenti di Aldini. La descrive così Katryn Harkup nel suo saggio La nascita di Frankenstein (2025, Utet editore): «Ogni muscolo fu scosso da potenti convulsioni, come se il corpo tremasse per il freddo. Dopo alcuni aggiustamenti, la macchina fu collegata una seconda volta. Allora partì una respirazione completa e affannosa. L’addome si distese, il petto si sollevò e si abbassò. Con l’ultima scossa elettrica, le dita della mano destra iniziarono a contrarsi, come se premessero le corde di un violino. Poi un dito si allungò e sembrò indicare qualcosa».
Impossibile non sentire, in questa descrizione, l’eco degli esperimenti italiani. Quel dito che si allunga, che sembra indicare qualcosa, ricorda persino il dito di Dio nella Creazione di Michelangelo, nella Cappella Sistina. Un gioco di rimandi piuttosto articolato: dall’arte italiana alla scienza italiana, fino alla letteratura inglese che fonda un genere nuovo.
Victor Frankenstein parlava italiano?
Portiamo il discorso a un livello successivo. Dunque, se Mary Shelley si ispirò a Galvani e Aldini, bisognerebbe forse riconoscere che Victor Frankenstein – lo scienziato – aveva qualcosa di italiano nel sangue? O quanto meno che la sua scoperta, quella che lo portò a sfidare Dio e la natura, affondava le radici nella terra dove Galvani appendeva le sue rane? Probabilmente sì.
Non si tratta ovviamente di una questione di nazionalità, quanto piuttosto di genealogia dell’immaginario. La fantascienza moderna, che oggi ci regala film come quello di Guillermo del Toro, nasce da quella notte buia e tempestosa. Una notte che si potrebbe definire «illuminata dalla luce tremolante degli esperimenti bolognesi con le rane e i fulmini».
L’eredità di una tragedia
Mary Shelley visse una vita segnata da tragedie continue: la madre morta di parto, una sorella suicida, due figli perduti da piccoli. E poi i compagni di quella notte magica: Byron morto giovane a Missolungi, combattendo per l’indipendenza greca; il marito Percy annegato nel Mar Ligure, al largo di Portovenere, nel golfo che da allora porta il nome di Golfo dei Poeti. Forse è proprio dal dolore, dalla perdita insopportabile, che nasce il sogno impossibile di Frankenstein: riportare in vita chi abbiamo amato.
Mentre sfogliamo le pagine del romanzo o guardiamo il film su Netflix, dobbiamo ricordare anche questo: che una delle opere più famose della letteratura mondiale deve qualcosa all’Italia. Alle rane di Bologna, ai fulmini sui cadaveri, a quegli scienziati «pazzi» che osarono interrogare la natura sul segreto della vita. E forse, in fondo, è giusto così. Perché la grande letteratura nasce sempre dall’incrocio di strade diverse, da una notte tempestosa sul lago di Ginevra dove si mescolavano Italia e Inghilterra, poesia e scienza, vita e morte.