Francesco Saverio Vetere. La Storia dell’USPI e la mia storia
- Postato il 31 luglio 2025
- Editoria/Giornalismo
- Di Paese Italia Press
- 1 Visualizzazioni

A Giovandomenico Zuccalà e Carmelo Garofalo
Con affetto e gratitudine, in morte come in vita
(Francesco Saverio Vetere)
Roma, 31 luglio 2025 – Celebrare settant’anni di vita dell’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) significa attraversare la storia dell’informazione italiana, e nel mio caso significa anche ripercorrere la mia stessa vita professionale e personale intrecciata a quella dell’associazione. Ricordo ancora la giornata di festa per il 70° anniversario dell’ USPI, il 19 giugno 2023, nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama.
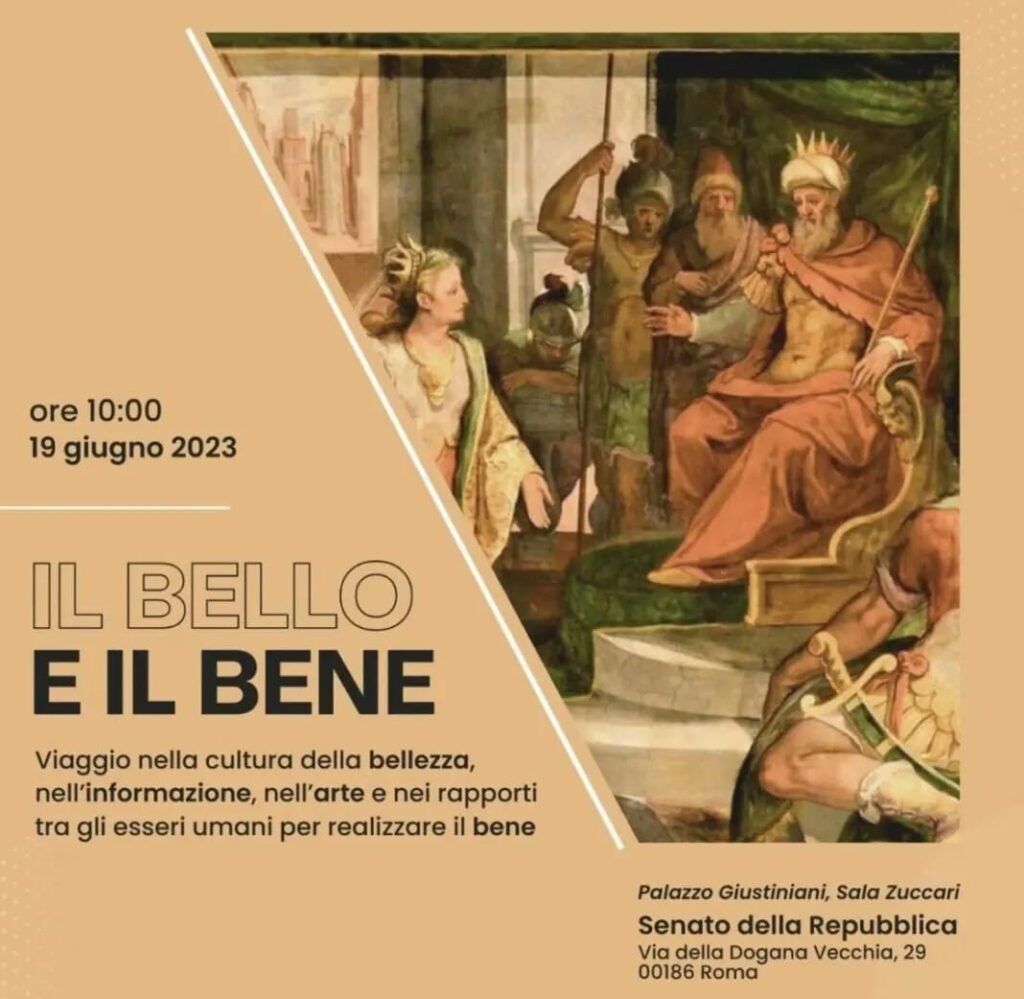
In quell’occasione scelsi come tema “Il bello e il bene”, un titolo impegnativo che rifletteva la mia convinzione profonda: anche nell’evoluzione frenetica dei media, esiste un nucleo di valori senza tempo – la ricerca del bene, della verità e della bellezza – che deve guidarci. Da appassionato di filosofia, tornato dopo anni di peregrinazioni moderne ai classici di Platone, sentivo che quell’anniversario non doveva essere solo celebrazione storica, ma un momento di riflessione sui princìpi fondanti del nostro lavoro.

(19 giugno 2023)

( 70 anni di Uspi 1953 – 2023)
La Settima Lettera di Platone, con il suo tono intimo e meditativo, mi ispirava a rivolgermi ai colleghi e amici come da persona a persone, con autenticità. Così inizio questo racconto in prima persona, con la voce di chi ha vissuto dall’interno le trasformazioni epocali della comunicazione, cercando di mantenere sempre fermo il timone dei propri valori.
Alle origini: l’USPI nel 1953 e gli anni della ricostruzione
L’USPI nacque nel 1953, agli albori della ricostruzione italiana nel dopoguerra. Non ero ancora nato, ma ho imparato a sentire come mio quel momento fondativo: il 18 giugno 1953, su iniziativa di Gianni Robert, si costituì l’Unione Stampa Periodica Italiana. L’idea originaria era nobile e lungimirante: creare un’organizzazione che tutelasse la stampa periodica culturale e scientifica, riunendo insieme editori e giornalisti in uno spirito associativo inclusivo, proprio come già avveniva alla fine dell’Ottocento con la vecchia ASPI (Associazione Stampa Periodica Italiana). In quegli anni della ricostruzione repubblicana, l’informazione periodica era un settore vitale per diffondere idee, conoscenza e dibattito culturale. Eppure, era anche un settore fragile, spesso ignorato dai grandi centri di potere editoriale concentrati sui quotidiani nazionali. L’USPI fu concepita come una “casa comune” dei piccoli e medi editori, un luogo dove unire le forze per rivendicare la dignità della stampa periodica nel panorama informativo italiano.
Mi piace immaginare l’entusiasmo e la determinazione di quei pionieri nel 1953: in un’Italia che gettava le fondamenta della democrazia repubblicana, anche l’informazione doveva essere pluralista e libera. Sin dall’inizio, l’USPI cercò di inserirsi “nella storia dei media a livello nazionale e internazionale”, consapevole che la vicenda della stampa periodica italiana non poteva essere isolata dal contesto più ampio. Gli anni Cinquanta posero sfide enormi: alfabetizzazione da ampliare, ferite della guerra da rimarginare, un pubblico da riconquistare alla lettura. L’USPI, nei suoi primi passi, si dedicò a censire le testate esistenti, a documentare la ricchezza di periodici italiani grandi e piccoli e a gettare ponti tra editori e giornalisti, anche provando a risolvere conflitti e a stabilire regole deontologiche comuni. Erano anni in cui l’associazione doveva ancora definire il proprio ruolo, ma un principio chiaro già la guidava – tutelare la libertà e il pluralismo dell’informazione periodica, specialmente nei settori meno sostenuti dai grandi capitali.
Anni di sfide e crescita (1960-1970)
Negli anni Sessanta e Settanta, l’USPI visse una fase di crescita e consolidamento, pur navigando in un contesto non facile. Sotto la guida di figure come Giovanni Terranova, l’Unione ampliò la base associativa per includere sempre più periodici locali, e iniziò a offrire servizi concreti ai soci – formazione professionale, consulenza editoriale e legale, assistenza fiscale. Era il tentativo di passare da una semplice federazione ideale a un supporto pratico quotidiano per chi faceva informazione nelle province, nelle parrocchie, nelle piccole comunità scientifiche e culturali. L’editoria periodica non doveva più sentirsi sola: l’USPI voleva essere al fianco di ogni editore con consigli e strumenti per migliorare i propri prodotti e difendere i propri diritti.
Quelli furono anche anni turbolenti per l’Italia: il boom economico, le tensioni sociali e politiche dei tardi ’60, la stagione complessa degli anni di piombo nei ’70. La stampa periodica rifletteva queste trasformazioni, oscillando tra fermento culturale e crisi economiche. Giovanni Terranova e dopo di lui il Segretario Generale Gian Domenico Zuccalà (che assumerà la carica nel 1972) dovettero battersi perché la voce dei piccoli editori non venisse schiacciata dal rumore dei potenti. Zuccalà in particolare iniziò a rafforzare i rapporti dell’USPI con le istituzioni e i governi, rivendicando un riconoscimento ufficiale per la categoria. Si trattava di far capire ai politici che le riviste, i bollettini locali, le pubblicazioni scientifiche minori avevano un valore culturale e sociale immenso, e meritavano attenzione e sostegno al pari dei grandi quotidiani nazionali. Nonostante l’impegno, la visibilità dell’editoria medio-piccola restava faticosamente parziale: l’USPI doveva continuamente riaffermarne il valore, in un paese dove l’opinione pubblica e i finanziamenti statali tendevano a concentrarsi sui media più potenti.
Una battaglia fondamentale di quegli anni riguardò le agevolazioni fiscali e postali per i periodici. Zuccalà adottò una strategia quasi sindacale per ottenere condizioni migliori: tariffe postali ridotte, carte a prezzi calmierati, e soprattutto qualche forma di contributo pubblico per la stampa “minore”. Il risultato più significativo fu l’ottenimento della Legge n. 172/1975, che sancì i primi benefici statali per l’editoria periodica minore. Per la prima volta nella storia repubblicana si riconosceva con una legge che anche le piccole testate meritavano sostegni economici. Fu una vittoria importante, ma non risolutiva: l’applicazione di quella legge rivelò lacune, risorse insufficienti e burocrazia complicata. Inoltre, occorreva una visione normativa più ampia per sostenere davvero il pluralismo. Eppure, quell’atto del 1975 resta una pietra miliare: ricordo come negli anni successivi si continuò a citare quel primo passo, a dimostrazione che l’USPI sapeva passare dalle parole ai fatti, portando a casa risultati tangibili.
Accanto a questo, l’USPI intuì l’importanza di coinvolgere le neonate Regioni (introdotte proprio nei ’70) nel sostegno alla stampa locale. Vennero lanciate proposte innovative, come la creazione di centri stampa regionali o leggi regionali ad hoc per i periodici locali. Solo alcune regioni raccolsero l’invito, offrendo contributi o convenzioni, mentre altre rimasero sorde. Tuttavia, il messaggio era lanciato: l’informazione di prossimità, radicata nei territori, aveva bisogno di reti di supporto decentrate, non poteva dipendere solo da Roma. Questa visione anticipava in qualche modo l’idea moderna di glocalità – pensare globalmente, agire localmente – e l’USPI fu tra i primi a sostenere che la stampa regionale dovesse diventare protagonista delle politiche culturali.
Sul finire degli anni ’70 l’associazione fece scelte cruciali anche sul piano identitario: nel 1978 l’USPI si diede un nuovo Statuto, e poco dopo – nel 1987 – si ridefinì formalmente come sindacato di editori. Questo passaggio segnò l’accento sulla natura imprenditoriale dei membri: non si trattava solo di affermare principi, bisognava anche tutelare gli editori come aziende, aiutarli a stare sul mercato. L’USPI cominciò ad accogliere tra i soci anche editori medio-grandi, purché indipendenti e “puri” (cioè non legati ad altri interessi economici estranei all’editoria). Si voleva mantenere fede a un ideale: l’editore puro, che fa giornali per passione civile e professione, contrapposto agli editori impuri che usano le testate solo come strumenti di potere o influenza. Io stesso, molti anni dopo, avrei spesso ripreso questa distinzione parlando agli studenti: c’è chi fa informazione per raccontare il Paese, e chi la fa per interessi privati – una differenza capitale. Negli anni Settanta e Ottanta l’USPI già combatteva queste battaglie di principio, cercando al contempo soluzioni pratiche per la sopravvivenza dei piccoli editori.
Trasformazioni e resistenza (1980-1990)
Gli anni Ottanta portarono trasformazioni rapide nel mondo dei media, e nuove sfide per l’USPI. Personalmente, furono gli anni della mia formazione universitaria e dell’ingresso nell’età adulta. Sono nato nel 1962 a Cosenza, in Calabria, e in quel decennio degli Ottanta mi trovavo a Roma per gli studi universitari: mi ero iscritto a Giurisprudenza all’Università “La Sapienza”, seguendo un percorso che mio padre – avvocato anche lui – aveva immaginato per me. Parallelamente, coltivavo interessi umanistici profondi: provenendo da un liceo classico (il “B. Telesio” di Cosenza) dove il greco e il latino hanno forgiato la mia mente, non ho mai abbandonato la passione per la filosofia e la storia. Questa doppia anima, giuridica e umanistica, avrebbe in seguito orientato molto del mio modo di operare. Ma negli anni Ottanta ero ancora un osservatore esterno delle vicende editoriali, pur sentendomene intimamente attratto.
Intanto l’USPI si muoveva in un contesto in rapida evoluzione. Nel 1981 era stata varata la Legge 416, una riforma importante a sostegno dell’editoria (pensata soprattutto per i quotidiani, ma con qualche estensione ai periodici). L’USPI aveva contribuito attivamente alla stesura di quella legge, portando l’attenzione del legislatore anche sui bisogni delle riviste e dei giornali locali. La 416/1981 introdusse innovazioni come contributi finanziari, agevolazioni e ristrutturazioni del settore, ma la sua applicazione non fu semplice: troppa burocrazia, e ancora una volta i grandi gruppi finirono per avvantaggiarsene più dei piccoli. Ciò non scoraggiò l’USPI, che continuò a focalizzarsi sul migliorare le condizioni economiche dell’editoria minore, insistendo sulla necessità di alleggerire i costi e incentivare l’uso di nuove tecnologie digitali per rendere più efficiente la produzione.
Già a metà degli anni Ottanta, infatti, si intravedevano segnali della rivoluzione digitale che sarebbe esplosa di lì a poco. I primi personal computer, le tecniche di impaginazione elettronica, le reti telematiche sperimentali: il mondo editoriale iniziava a cambiare pelle. Per i piccoli editori, queste trasformazioni erano un’arma a doppio taglio. Da un lato, offrivano strumenti nuovi per produrre contenuti a costi minori; dall’altro, aumentavano la competizione, perché i gruppi editoriali più forti potevano investire in tecnologia e sfruttare le economie di scala, lasciando indietro i più piccoli. La figura tradizionale dell’editore artigianale, del “fai da te”, rischiava di scomparire. Molte testate minori chiusero, sopraffatte dai costi e dall’incapacità di stare al passo. Solo chi ebbe il coraggio e la possibilità di modernizzarsi e professionalizzarsi riuscì a sopravvivere in quel decennio.
L’USPI non stava a guardare. Nei congressi di metà anni ’80 si parlò esplicitamente della necessità di innovare e adattarsi, di puntare sulla specializzazione dei contenuti e sul legame col territorio come punti di forza della piccola editoria. Si capì anche che l’editore “tuttofare” doveva lasciare spazio a competenze nuove: da qui nacque l’idea di contribuire alla formazione dei giovani editori. Dal 1988 l’USPI, in collaborazione con l’Università di Urbino, organizzò stage estivi per i praticanti editori, corsi intensivi di sociologia della comunicazione, diritto editoriale, gestione aziendale. Io stesso, all’epoca poco più che venticinquenne, lessi con interesse di queste iniziative pionieristiche: mi affascinava l’idea di unire pratica e teoria, impresa e cultura. Non sapevo ancora che il mio destino professionale sarebbe passato proprio per l’USPI, ma già sentivo una naturale sintonia con quell’approccio. Ero un giovane giurista immerso nei codici, ma sognavo un lavoro che avesse un impatto culturale più ampio – il mondo dell’editoria e del giornalismo lo sentivo pulsare come una vocazione in sottofondo.
Gli anni Ottanta, poi, videro intensificarsi la lotta per i contributi pubblici all’editoria. Sul finire del decennio, con la crisi del sistema tradizionale di sovvenzioni, l’USPI si batté con forza contro l’idea di tagliare gli aiuti ai periodici minori. In Parlamento e presso il Governo, i nostri rappresentanti argomentavano che senza sostegni mirati molte voci sarebbero morte, impoverendo il pluralismo informativo. Si ottennero alcuni risultati: la Legge 67/1987 ad esempio abbassò l’IVA sulle riviste culturali e previde contributi specifici per esse. Ma la tendenza all’austerità era iniziata: progressivamente gli aiuti statali calarono, e questo spinse gli editori a fare da soli, costruendo una mentalità più imprenditoriale e autonoma. Una lezione difficile ma utile, perché in fondo l’indipendenza economica è sorella dell’indipendenza editoriale. Anch’io, come uomo del sud avvezzo alle sfide, ho sempre pensato che l’autonomia e la capacità di innovare fossero le chiavi per non dover chinare la testa di fronte a nessuno.
Il mio ingresso nel mondo dell’editoria (anni 1990)
I primi anni ’90 segnarono un punto di svolta, sia per l’USPI sia per me personalmente. Dopo la laurea in Giurisprudenza, scelsi di rimanere a Roma. Mi abilitai come avvocato e poi come avvocato cassazionista, ma allo stesso tempo iniziai a collaborare con l’Università e a coltivare studi manageriali, conseguendo in seguito anche una seconda laurea magistrale in Management delle organizzazioni pubbliche. Eppure, il richiamo dell’editoria era sempre più forte. Fu attorno alla metà degli anni ’90 che feci il mio ingresso effettivo nel settore editoriale – ed è un momento che ricordo vividamente, perché significò immergersi in un mondo tanto affascinante quanto complicato.
Entrai in contatto con l’USPI proprio in quel periodo, a metà degli anni ’90, portando le mie competenze legali e la mia formazione rigorosa al servizio di questa organizzazione. Sin dai primi passi, mi resi conto che il sistema editoriale italiano in cui mi stavo immergendo era “specifico e molto chiuso, infestato e dominato dalle lobby dei grandi giornali e del grande sindacato giornalistico”. Venivo da un’educazione classica e giuridica che mi aveva insegnato il valore della logica e della serietà argomentativa, e all’inizio rimasi spiazzato nel trovare un ambiente dove spesso a prevalere erano le rendite di posizione, l’arroganza di chi occupava da decenni posizioni di potere nel settore, e una chiusura pregiudiziale verso ogni cambiamento. L’editoria italiana di allora era governata da poche grandi famiglie editoriali e da un sindacato giornalistico fortissimo (l’Ordine e la FNSI), che insieme formavano un blocco quasi impenetrabile. I piccoli editori, il mondo fuori dai grandi quotidiani, erano considerati poco più che comparse. Questo status quo generava ingessature e ingiustizie: contratti di lavoro unici calibrati sui grandi giornali, contributi pubblici intercettati in buona parte dai colossi e dai giornali di partito, scarsa considerazione per le testate locali o specializzate.
Eppure, proprio in quegli anni ’90, stava per abbattersi sul mondo dell’informazione una trasformazione epocale. Dopo pochi anni dal mio ingresso, il mondo cambiò – e la tecnologia lo devastò nelle sue vecchie strutture, rendendole improvvisamente inattuali e superate. Mi riferisco ovviamente all’avvento di Internet e del digitale. Tra il 1995 e il 2000, l’accelerazione tecnologica fu impressionante: nascevano i primi siti web d’informazione, le email rivoluzionavano la comunicazione, i cellulari iniziavano a diventare strumenti di connessione e non solo di chiamata. Quel sistema editoriale italiano che mi era apparso all’inizio “arrogante, inutilmente complesso e profondamente sciocco” si rivelò nel giro di poco tempo non solo tutto questo, ma addirittura “dannoso e irrilevante” nella nuova era. Ricordo la sensazione di osservare colossi dai piedi d’argilla: i grandi che avevano dominato l’industria non volevano accettare che il mondo fosse cambiato. Molti continuarono ad agire come se nulla fosse, appesantiti e zavorrati dalle lobby interne che impedivano lo sviluppo del pensiero e delle visioni associative. Tra me e me, citando liberamente la Scrittura, pensavo: «ti si crede vivo e invece sei morto». Quelle strutture parevano vive, ma non lo erano più davvero, incapaci di evolvere.
In quel frangente storico drammatico e affascinante insieme, sentivo che solo pochi lucidi osservatori coglievano la portata del cambiamento, e vorrei dire con modestia che io fui tra quelli. Forse aiutato proprio dalla mia formazione “antica” (che mi rendeva estremamente sensibile ai fondamenti, alle radici dei problemi) riuscii a scorgere, dietro il rumore delle novità tecnologiche, i principi eterni che andavano salvaguardati. Sì, cambiavano gli strumenti, ma certi valori dovevano rimanere il faro. E l’USPI – ne ero convinto – poteva e doveva giocare un ruolo cruciale: “mettersi a disposizione degli editori, ma al contempo interpretare le trasformazioni per ridefinire un sistema editoriale capace di salvaguardare la libertà di informazione” anche nel nuovo millennio.
Questa convinzione si fece strada in me proprio mentre l’USPI viveva una transizione di leadership. Nel 1998 il Presidente storico Dario Di Gravio lasciò il posto a Mario Negri, e l’anno seguente (1999) il Segretario Generale Gian Domenico Zuccalà – che tanto aveva dato all’associazione in quasi trent’anni di servizio – venne a mancare. Fu così che, nel novembre 1999, venni scelto come Segretario Generale dell’USPI, assumendo anche la presidenza della Giunta Esecutiva. Avevo 37 anni. Ricordo ancora l’emozione e il peso di quella nomina: da un lato la fierezza di guidare un’istituzione nazionale, dall’altro la chiara percezione che mi attendeva un compito arduo. L’USPI in quel momento era sì una “cellula viva” della grande stampa italiana, come qualcuno l’ha definita, ma andava rilanciata e ripensata per i tempi nuovi.

Mi promisi che avrei dedicato tutte le mie energie – e la mia famosa ostinazione calabrese, quel tratto di carattere “duro” e caparbio che molti mi riconoscono – a questa missione.
Rinnovamento e nuove battaglie (2000-2010)
Assumere la guida dell’USPI nel 1999 significò per me mettere immediatamente mano a un progetto di rinnovamento profondo dell’associazione. Volevo traghettarla nel XXI secolo, e per farlo dovevo trasformare la struttura interna e al tempo stesso combattere diverse battaglie esterne a favore degli editori. Iniziai da dentro: l’USPI non poteva più essere un semplice “apparato di segreteria” semi-burocratico, dove poche persone facevano di tutto. Organizzai il team in modo moderno, assegnando ogni funzionario a un settore specifico – chi si occupava di distribuzione, chi di questioni legali, chi di contrattualistica, e così via. Coinvolgemmo consulenti esterni qualificati, specializzati nel diritto editoriale e del lavoro, per dare risposte esperte ai soci. Informatizzammo gli uffici, rinnovammo completamente il sito web dell’USPI (che doveva diventare una piattaforma ricca di notizie, aggiornamenti normativi, circolari utili). Avviammo perfino nuovi spazi fisici: una Biblioteca USPI e un auditorium per incontri e convegni, perché l’associazione doveva essere non solo un ente di servizi ma anche un luogo di cultura e dibattito. Nel giro di pochi anni, vidi con soddisfazione crescere il numero dei soci e l’utilizzo dei servizi: le consulenze richieste dagli associati salirono da poche centinaia a quasi cinquecento al mese – segno che gli editori finalmente vedevano nell’USPI un riferimento concreto per i loro problemi quotidiani.
Parallelamente al rinnovamento interno, mi gettai anima e corpo nelle battaglie istituzionali a difesa della stampa periodica. Una delle prime urgenze fu la questione delle tariffe postali agevolate: un tema annoso, ma che rischiava di precipitare. Già dagli anni ’90 l’USPI lottava contro i rincari postali che penalizzavano le riviste (storicamente, dal 1981 avevamo ottenuto uno sconto del 50% sulle tariffe). Alla fine del ’99 ci trovammo di fronte a una proposta di riforma che mirava ad eliminare le agevolazioni tradizionali sostituendole con un sistema di rimborsi esigui. Questo, per molti piccoli editori, avrebbe significato non poter più spedire le proprie pubblicazioni ai lettori per abbonamento, con conseguenze disastrose. Decisi che non potevamo cedere su questo fronte: mi attivai subito, incontrando rappresentanti di governo e parlamentari di varie forze politiche, spiegando con dati e passione cosa avrebbe comportato quella riforma. Riuscimmo a ottenere un rinvio: la temuta riforma delle tariffe fu posticipata fino al 2003, guadagnando tempo prezioso e salvando nel frattempo molte testate da gravissime difficoltà economiche. Fu una vittoria significativa: l’USPI mostrava che sapeva farsi ascoltare, sapeva spendere la propria autorevolezza per il bene degli associati.
Un altro capitolo fondamentale fu la partecipazione attiva alla grande riforma dell’editoria varata nel 2001, la Legge n. 62/2001. Quel provvedimento legislativo fu un contenitore di molte misure per aggiornare il settore alle soglie del nuovo millennio, e l’USPI vi contribuì con numerose proposte. Ne cito alcune di cui vado particolarmente fiero: nella legge 62/2001 si introdusse per la prima volta la definizione di “prodotto editoriale” comprensiva anche delle pubblicazioni online, colmando un vuoto normativo e riconoscendo dignità giuridica alle testate telematiche. Inoltre, la legge semplificò le procedure per l’accesso al credito agevolato per gli editori e predispose nuovi sostegni alla stampa di elevato valore culturale (misure pensate proprio per quelle riviste letterarie, scientifiche, locali di qualità che l’USPI da sempre tutela). Posso dire, senza enfasi, che in quelle norme è impresso il lavoro silenzioso ma tenace che conducemmo in quei mesi: la voce dell’USPI fu ascoltata, e il risultato fu un quadro normativo più inclusivo e moderno.
Quegli anni a cavallo del 2000 videro anche l’USPI impegnata a capire e governare il fenomeno dell’editoria online. Come accennavo, già dalla fine dei ’90 molti periodici cartacei iniziarono a sperimentare la migrazione su Internet. All’inizio fu un processo pieno di difficoltà: qualcuno pensava bastasse mettere in rete il PDF del giornale, altri non sapevano come monetizzare i contenuti digitali, e i ricavi pubblicitari online erano scarsi. Io stesso partecipai all’organizzazione di un Forum a Frascati nel 2000, dove invitammo esperti, editori e accademici a discutere la “rivoluzione telematica” per la stampa locale. Ricordo un atteggiamento diffuso di prudenza se non di scetticismo: molti piccoli editori temevano che Internet fosse una moda passeggera o comunque un investimento troppo oneroso e incerto. E in effetti, nei primi anni 2000, parecchi provarono a lanciarsi nel web ma poi, di fronte ai “scarsi ricavi pubblicitari online”, tornarono alla carta. Era una tensione continua tra innovazione e tradizione, una bilancia difficile da equilibrare.
Nonostante ciò, il futuro stava arrivando a grandi passi. Già nel 2002 facemmo una scelta storica: l’USPI iniziò a rappresentare formalmente i periodici elettronici, ammettendoli nell’associazione. Questo segnò l’apertura totale al nuovo: riconoscemmo che un giornale online, anche privo di equivalente cartaceo, era a tutti gli effetti un giornale, una testata, con i suoi diritti e doveri. Fu un modo per includere tanti nuovi soggetti – testate locali nate sul web, blog giornalistici, portali d’informazione – che altrimenti sarebbero rimasti ai margini senza rappresentanza. Personalmente, considerai questo passo come coerente col DNA originario dell’USPI: nel 1953 avevamo accolto riviste culturali e scientifiche ignorate dai più, nel 2002 accoglievamo testate digitali ancora non pienamente considerate dal sistema. Il pluralismo evolutivo dell’informazione era la nostra stella polare.
In quegli stessi anni lavorammo anche sul fronte internazionale. Nel 2002 sottoscrivemmo un protocollo d’intesa con la FUSIE (Federazione della Stampa Italiana all’Estero) per creare un Coordinamento mondiale della Stampa Periodica Italiana. L’idea era di collegare in rete i giornali degli italiani nel mondo, condividere esperienze e dare voce ai milioni di connazionali all’estero che attraverso quei periodici mantenevano un legame con la madrepatria. Organizzammo convegni, mostre di stampa italiana a Varsavia, in vari paesi europei, persino in Cina, portando in giro per il mondo l’idea che la stampa periodica italiana, nella sua varietà, è ambasciatrice di cultura. Fu un periodo entusiasmante, in cui io – calabrese trapiantato a Roma – mi ritrovai a dialogare con editori di Buenos Aires, di Toronto, di Melbourne, scoprendo che ovunque batteva un cuore tricolore c’era un piccolo giornale, una rivista, una newsletter che teneva viva la nostra lingua e le nostre tradizioni. Eravamo riusciti a dare anche a loro una casa comune.
Verso il futuro digitale (2010-2020)
L’ingresso nel secondo decennio degli anni 2000 portò con sé ulteriori cambiamenti profondi, forse i più dirompenti di sempre. In poco più di dieci anni, la rivoluzione digitale ha stravolto modelli di business, abitudini di lettura, forme di linguaggio. L’USPI, forte dell’adattamento iniziato già nei primi anni 2000, ha continuato a giocare un ruolo cruciale nell’aiutare gli editori a navigare questo panorama in continua evoluzione. Ma non è stato semplice, né lo è tuttora.
Intorno al 2010, con l’avvento massiccio dei social network, dei blog, dei podcast, il concetto stesso di “testata” giornalistica si è fatto liquido. All’inizio degli anni 2000 c’era ancora distinzione netta tra testate registrate e non, tra prodotto giornalistico e contenuti amatoriali. Oggi quei confini si sono sfumati: chiunque può creare un sito d’informazione, una pagina Facebook di notizie, un canale YouTube. L’USPI ha dovuto affrontare un quesito cruciale: come difendere i valori del giornalismo professionale in un ecosistema dove proliferano attori nuovi e non regolati? La nostra risposta è stata duplice: da un lato, includere queste nuove forme dentro il nostro orizzonte; dall’altro, promuovere regole e tutele equivalenti per chi fa informazione, indipendentemente dal medium utilizzato.
Così, abbiamo incoraggiato gli editori a estendere ai collaboratori online gli stessi diritti e trattamenti dei colleghi della carta stampata. Abbiamo sostenuto, ad esempio, che un redattore di un giornale digitale locale merita un contratto dignitoso come quello di un redattore di un settimanale cartaceo.

Questo impegno ha portato ad una delle realizzazioni di cui vado più fiero: la firma, nel febbraio 2023, di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico tra USPI e FIGEC-CISAL. Era dal 2018 che lavoravamo a questo obiettivo, per dare una casa contrattuale ai tanti giornalisti “non riconosciuti” dal contratto tradizionale FIEG-FNSI. Il nuovo contratto riconosce le mutate esigenze del mondo editoriale e finalmente risponde alle problematiche dei lavoratori del settore. Ha introdotto aumenti retributivi di oltre il 5% (retroattivi al 1º gennaio 2023) per tutti i lavoratori; ha ampliato le figure professionali riconosciute includendo ruoli prima ignorati (dal **caporedattore all’inviato, fino al “vaticanista” e ai nuovi profili digitali); ha potenziato le tutele con contributi per la previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa gratuita e permessi retribuiti per l’aggiornamento professionale. Inoltre – e questo ci tengo a sottolinearlo perché riflette la nostra sensibilità umanistica – abbiamo inserito disposizioni che rispettano le diversità religiose dei lavoratori, riconoscendo per la prima volta la domenica di Pasqua come giorno festivo contrattuale e dando la possibilità ai non cattolici di sostituire alcune festività con quelle della propria fede. Infine, il contratto ha rinnovato l’accordo sul lavoro autonomo garantendo un compenso minimo ai collaboratori coordinati e continuativi, e introducendo una clausola di garanzia per il pagamento proporzionale delle prestazioni. È un risultato epocale: dopo decenni di immobilismo contrattuale, USPI e una nuova federazione di giornalisti (FIGEC) hanno prodotto uno strumento innovativo, tarato sulla realtà odierna che vede fianco a fianco redattori tradizionali e operatori dell’informazione digitale. Ne sono profondamente orgoglioso, perché credo stabilisca finalmente punti fermi per la tutela del lavoro giornalistico e l’affermazione della sua dignità in tutte le forme in cui esso si esplica.
Naturalmente, non sono mancate le critiche. Qualcuno – in mala fede o per difesa di interessi particolari – ha sostenuto che il nostro contratto “abbasserebbe” gli stipendi uniformandoli a quelli di altri settori, o che frammentare i contratti per categorie indebolirebbe la categoria. A queste voci rispondo sempre con i fatti: il nostro CCNL ha incrementato le retribuzioni medie e ha esteso diritti a chi prima ne aveva pochissimi; lungi dal dividere la categoria, ha incluso fasce di lavoratori che prima erano esclusi da ogni tutela. Certo, resta aperta la domanda se un giorno si potrà superare l’idea stessa di contratto nazionale unico per lasciare spazio solo a contratti aziendali o individuali – è un tema di dibattito legittimo in un mondo così frammentato. Ma finché il contratto collettivo rimane “l’unica forma possibile” di tutela generale, noi abbiamo l’obbligo di plasmarlo in modo plurale e al passo coi tempi. La pluralità contrattuale, rispecchiando la pluralità dei soggetti del settore, è a mio avviso una ricchezza e non una debolezza.
Parallelamente alla questione dei contratti, negli anni 2010 l’USPI ha dovuto fronteggiare la crisi dei contributi pubblici all’editoria. Ricordo bene il 2018, quando un provvedimento inserito in Legge di Bilancio (il famigerato “comma Crimi”) decretò la graduale eliminazione nel giro di pochi anni di tutti i sostegni statali alla stampa. Fu un colpo durissimo, soprattutto perché mirava dritto al cuore delle realtà medio-piccole che più dipendono da quei contributi per sopravvivere. Cambiarono governi, cambiarono sottosegretari, ma quella norma non venne mai abrogata – solo prorogata, rimandando di anno in anno l’esecuzione della “sentenza”. Questa incertezza ha creato ansia e precarietà diffuse nel settore, e l’USPI, assieme ad altre associazioni, ha levato alta la voce per ricordare che senza un sostegno pubblico il pluralismo va in crisi. Abbiamo dialogato con il Quirinale, con il Parlamento, con chiunque volesse ascoltare, spiegando che i contributi all’editoria non sono un privilegio ma un investimento democratico: servono a tenere in vita testate nelle minoranze linguistiche, giornali di idee, periodici di frontiera che altrimenti verrebbero spazzati via dal mercato. Su questo tema la battaglia è ancora aperta, e io la vivo come una questione morale prima ancora che economica: difendere i piccoli editori dal taglio dei fondi significa difendere il diritto dei cittadini a una informazione plurale e diffusa. Spero che le istituzioni trovino la saggezza di ripensarci, perché un Paese senza voci indipendenti è un Paese più povero e meno libero.
In questi anni l’USPI si è anche attivata per essere presente nei contesti decisionali più ampi: dal Registro per la trasparenza UE (dove siamo iscritti dal 2021 come rappresentanti di interessi del settore editoriale), ai tavoli ministeriali e alle commissioni tecniche, noi portiamo sempre l’istanza dei periodici italiani. Personalmente, ho avuto l’onore di sedere in commissioni presso la Presidenza del Consiglio, di coordinare organismi di settore, di essere invitato come docente o esperto a convegni in tutta Italia. Porto sempre con me il bagaglio delle mie origini e della mia esperienza: un avvocato calabrese trapiantato a Roma che cerca di far valere le ragioni di chi non ha grandi lobby alle spalle. E devo dire che, se l’USPI è arrivata a 70 anni di servizio, qualcosa di buono lo abbiamo seminato. Spesso mi chiedono: “Ma è servito a qualcosa tutto questo impegno?” Io rispondo con quello che ho detto in mille occasioni pubbliche: noi ci siamo messi continuamente “all’ascolto del mondo”. Abbiamo ascoltato dapprima il nostro piccolo mondo italiano, dove per decenni i giornali (soprattutto i quotidiani) per esistere hanno quasi sempre avuto bisogno di aiuti pubblici. Poi abbiamo aperto le orecchie alle dinamiche internazionali, cercando di comprenderne le trasformazioni e anticiparne gli effetti da noi. L’informazione cambia, si svincola progressivamente dall’idea classica di “giornale” come opera collettiva per frammentarsi in contenuti fruibili singolarmente. Ormai può essere un blog, una pagina social, un podcast, un video – qualunque cosa, purché sia informazione, cioè produzione regolare di contenuti informativi da parte di soggetti che seguono regole di mestiere. Questo è il punto: il mestiere giornalistico rimane, pur se cambia il formato. Non è più necessariamente “il giornale” di carta, ma resta il giornalismo. E l’USPI, con fatica ma con costanza, ha cercato di accompagnare questa evoluzione, di includere i nuovi media invece di combatterli, e di portare nel dibattito i principi di sempre.
Principi senza tempo in un mondo che cambia
Arrivo così a riflettere sui valori e le lezioni che questa lunga storia, dell’USPI e mia personale, ha insegnato. Mi sono spesso domandato: in questo mare magnum di cambiamenti tecnologici, sociali, culturali, non è che alla fine tutto si riduce a pochi semplici princìpi? Me lo chiedo con la coscienza di chi ha attraversato decenni che sembrano secoli. Quando iniziai, il mondo era analogico; oggi parliamo di intelligenza artificiale che scrive articoli. Eppure, ciò che fa la differenza, ciò che distingue un’informazione libera e autentica dal caos, sono a mio avviso la serietà e la sincerità di chi comunica. Me lo ripeto spesso: non mentire, non tradire la fiducia, non rubare la dignità al lettore. Questo è il fondamento più grande che il mio tempo mi ha lasciato e che voglio portare nel nuovo. In tutta la mia carriera, ho cercato di trasmettere questo messaggio: l’etica prima di tutto, l’onestà intellettuale come stella polare.
Questo significa, concretamente, lealtà nei confronti dei lettori. Storicamente la chiamavamo linea editoriale: dichiarare in anticipo ai lettori quali sono le proprie intenzioni, il proprio punto di vista, e poi essere coerenti. Se dico che pubblicherò un giornale fondato sulla fantasia e sulle emozioni, non tradisco nessuno se poi offro intrattenimento e storie emotive. Ma se pretendo di pubblicare un giornale (anche in forma di pagina social, oggi) lasciando intendere che racconterò la verità, e poi invece faccio propaganda o diffondo falsità, allora violo ogni principio di lealtà. Tutto si riduce a questo in fondo: un patto onesto con il lettore. Ho sempre difeso l’idea che il pubblico non va ingannato né trattato dall’alto in basso; al contrario, va rispettato al punto da condividere apertamente le proprie posizioni. Credo che il pluralismo nasca anche così: non dall’illusione di una impossibile totale neutralità, ma dalla convivenza di voci diverse, ciascuna intellettualmente onesta nel dichiararsi e nel basarsi sui fatti.
A questo proposito, una delle mie riflessioni costanti riguarda la differenza tra comunicazione e informazione professionale. Oggi tutti comunichiamo, di continuo: i social media hanno dato voce a miliardi di persone. La post-verità e la disinformazione prosperano in un ambiente dove ciò che colpisce di più – spesso il messaggio emozionale – viene diffuso maggiormente. Ma attenzione: se chiunque può comunicare qualunque cosa (ed è una libertà importante), il giornalismo è un’altra cosa. Se io scrivo un post sui social sto facendo un’attività di comunicazione personale che può obbedire a qualunque logica o istinto del momento; ma se faccio informazione professionale, il fondamento della mia opera deve essere la verità, mai la post-verità. È un discrimine netto. Purtroppo, nel dibattito pubblico c’è spesso confusione su questo. Si parla di “fake news”, di “informazione che ormai è tutta manipolata dalle emozioni”, come se fosse un fenomeno nato con Facebook. Io ricordo sempre che il predominio dell’emozione sulla verità non è affatto una novità del nostro tempo: già nel XIX secolo c’era lo “yellow journalism”, e in ogni epoca sono esistiti sia i racconti sensazionalistici sia il giornalismo rigoroso dei fatti. Dunque la post-verità esiste da quando esiste l’informazione, solo che oggi – con l’esponenziale aumento dei flussi comunicativi – rischia di sommergerci. E allora torno al punto: l’unica diga possibile è la deontologia, la professionalità, la fedeltà ai fatti verificati.

In questo, devo dire, l’USPI mi ha dato forza e io spero di aver dato direzione all’USPI. Possiamo orgogliosamente affermare che l’USPI non ha mai mentito ai suoi associati, ha sempre cercato di fare il proprio dovere di sostegno, tutela e assistenza. È un’affermazione forte, ma la rivendico con convinzione. Abbiamo commesso errori? Certo, chi non ne fa in settant’anni di storia. Ma mai abbiamo tradito la fiducia di chi contava su di noi, mai abbiamo deliberatamente sacrificato l’interesse generale degli editori minori per qualche vantaggio particolare. Questo per me è motivo di profondo orgoglio e dà senso a tante fatiche quotidiane.

Guardando avanti, le sfide non sono finite. Oggi parliamo di Intelligenza Artificiale, di algoritmi che selezionano le notizie, di possibili scrittori automatici di articoli. C’è chi prospetta uno scenario in cui le macchine rimpiazzano i giornalisti. Io non credo a una sostituzione totale – il pensiero critico umano, la capacità di contestualizzare e provare empatia, non potrà mai essere interamente simulata – ma è plausibile che l’IA influenzi il nostro mestiere, ridisegnando ruoli e competenze richieste. Anche qui, il mio approccio, e quello che cerco di trasmettere all’USPI, è proattivo: non possiamo fermare l’innovazione, dobbiamo piuttosto governarla. Significa cogliere le opportunità dell’IA (per esempio automatizzare le attività ripetitive, liberando tempo per l’approfondimento) e al contempo preservare la qualità e l’etica dell’informazione. Come sempre, non è la tecnologia in sé il nemico, ma l’uso che se ne fa.

Quando entro in aula all’Università – perché ho anche la fortuna di insegnare Storia della Stampa Periodica e Management dell’Editoria Periodica alla Sapienza di Roma – vedo nei volti dei miei studenti la stessa passione che avevo io alla loro età. A loro ripeto spesso: il futuro del giornalismo si giocherà sulla qualità dell’informazione libera, per quanto potrà esserlo, dai condizionamenti degli algoritmi. Dobbiamo puntare tutto sulla qualità fondata sulla verità, non sulla ricerca truffaldina di visualizzazioni. Questo credo sia il compito della prossima generazione: liberarsi sia dalle piccole logiche lobbistiche di categoria, sia dalle grandi logiche commerciali mascherate da libertà di internet. Ho visto con i miei occhi come certe piattaforme globali impongano di fatto un “certo linguaggio e un certo contenuto” se vuoi ottenere visibilità – e lo chiamano libertà!. Ecco, difendere la libertà oggi significa anche smascherare queste pseudo-libertà e rivendicare per i professionisti dell’informazione il diritto di non uniformarsi alle mode imposte dall’algoritmo di turno. Libertà è poter scegliere la qualità e la verità anche a costo di essere meno popolari, e sapere che esisterà comunque uno spazio per queste scelte coraggiose.In conclusione, se riguardo all’intreccio tra la storia dell’USPI e la mia vita, vedo un filo rosso: la passione per un ideale. È la passione che mi ha mosso fin da giovane – quel fuoco interiore che mi impedisce di vivere “freddamente” il mio lavoro – e che ha mosso generazioni di editori e giornalisti periodici in Italia. Senza passione non avrei sopportato le lunghe giornate (non di rado 14 ore filate di lavoro, come nota chi mi conosce), le sconfitte momentanee, le frustrazioni di vedere magari approvate leggi giuste ma poi applicate male. Senza passione l’USPI non sarebbe sopravvissuta a sette decenni di cambiamenti e crisi. La nostra forza vera è la passione, come dissi in quel discorso per l’anniversario. E alla passione ho sempre cercato di unire l’integrità e la coerenza con i princìpi. Platone, nel suo idealismo, insegna che il bene e il bello sono intimamente connessi e costituiscono il fine ultimo a cui tendere. Nel mio piccolo, ho sempre pensato che difendere la libertà di stampa, il pluralismo delle voci, la verità dei fatti fosse un modo di tendere al bene comune e di rendere più bella e giusta la società. Ogni volta che un piccolo giornale non chiude grazie a una legge che siamo riusciti a far approvare, ogni volta che un giovane cronista di provincia ottiene un contratto dignitoso grazie a una nostra iniziativa, ogni volta che una comunità locale vede rappresentata la propria voce su una testata invece di essere cancellata dal silenzio – ecco, in ognuna di queste vittorie io intravedo uno scorcio di quel bene superiore.

(USPI primi anni ’90)
Chiudo quindi questo mio viaggio narrativo così come l’avevo aperto: con un pensiero di gratitudine e di fiducia. Gratitudine verso chi mi ha preceduto e verso chi ha combattuto insieme a me – dai fondatori del 1953 fino ai colleghi attuali – perché se abbiamo potuto “cominciare dai princìpi” e mantenerli vivi, è merito di un impegno collettivo.

Carmelo Garofalo ( USPI 2007)
E fiducia nel futuro, nonostante tutto: perché la storia dell’USPI, intrecciata alla storia d’Italia, dimostra che si possono attraversare crisi tremende e uscirne rinnovati, senza tradire la propria essenza. Ho attraversato decenni di cambiamenti, come su un ponte sospeso tra un passato che non torna e un futuro incerto. Ma so che sotto i miei piedi quel ponte poggia su pilastri solidi: i valori di libertà, pluralismo e verità che ci definiscono. Finché non tradiremo questi valori, l’USPI – e io con essa – avrà motivo di esistere e di servire. E questa, in definitiva, è la missione che dà senso a tutta una vita.
@Riproduzione riservata
L'articolo Francesco Saverio Vetere. La Storia dell’USPI e la mia storia proviene da Paese Italia Press.

