Cosa accade quando un'ipotesi di lavoro scientifico entra nella centrifuga dei social
- Postato il 20 novembre 2025
- Di Il Foglio
- 1 Visualizzazioni
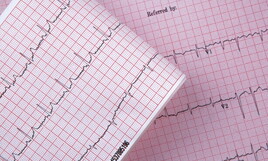
Cosa accade quando un'ipotesi di lavoro scientifico entra nella centrifuga dei social
Negli ultimi giorni si è parlato molto di un presunto aumento del rischio cardiaco legato all’uso prolungato di melatonina. In verità, quel che si trova nella fonte primaria, una comunicazione ufficiale dell’American Heart Association, è tutt’altro che un verdetto. Non c’è uno studio pubblicato. C’è un abstract, cioè un riassunto preliminare presentato a un convegno, privo di revisione paritaria. Gli autori stessi lo dichiarano: lo studio non è stato sottoposto a peer review e quindi non può essere considerato un risultato consolidato. Nella forma attuale, è semplicemente troppo debole per reggere la minima analisi critica.
E quando si scende nei dettagli, la fragilità metodologica diventa evidente. La fonte primaria elenca limiti che, da soli, basterebbero a sconsigliare qualsiasi conclusione. Ecco la traduzione esatta delle parti essenziali:
"Lo studio presenta diversi limiti. Per cominciare, il database include Paesi in cui la melatonina richiede una prescrizione (come il Regno Unito) e Paesi in cui ciò non è necessario (come gli Stati Uniti), e la localizzazione geografica dei pazienti non faceva parte dei dati anonimizzati disponibili per i ricercatori. Poiché l’uso di melatonina era identificato solo dalle registrazioni dei farmaci nelle cartelle cliniche elettroniche, chiunque assumesse melatonina come integratore da banco negli Stati Uniti o in altri Paesi in cui non serve la prescrizione sarebbe stato inserito nel gruppo dei non utilizzatori; di conseguenza, l’analisi potrebbe non riflettere accuratamente la realtà". Tradotto: migliaia di persone che prendono melatonina ogni giorno – negli Stati Uniti la usano fino a 6 milioni di adulti, secondo i dati nazionali – finiscono automaticamente nel gruppo “senza melatonina”. Un errore di classificazione sistematico che da solo renderebbe l’analisi inutilizzabile.
E ancora:
"Le cifre relative ai ricoveri erano più alte rispetto alle diagnosi iniziali di scompenso cardiaco perché nei ricoveri possono essere inseriti vari codici diagnostici correlati, e non necessariamente includono quello di una nuova diagnosi di scompenso cardiaco". Significa che nel database non sappiamo nemmeno se i ricoveri attribuiti allo scompenso cardiaco fossero davvero nuovi casi o semplici ricodifiche amministrative. Una distorsione talmente grossolana da rendere il dato inaffidabile.
E infine:
"I ricercatori non disponevano di informazioni sulla gravità dell’insonnia né sulla presenza di altri disturbi psichiatrici". Questa è la chiave di tutto. L’insonnia grave, la depressione, l’ansia, l’uso concomitante di altri farmaci sedativi sono tutti fattori associati a un rischio cardiovascolare maggiore, indipendentemente dalla melatonina. Se non li controlli, non puoi dire nulla sull’effetto della melatonina. Non è epidemiologia: è confusione.
Lo confermano gli stessi autori:
"Il nostro studio non può dimostrare una relazione diretta di causa-effetto. Serve più ricerca per valutare la sicurezza della melatonina per il cuore". Una frase chiarissima che smonta da sola qualsiasi interpretazione allarmistica. Capita spesso: un’associazione statistica debole, derivata da dati rumorosi e non controllati, viene trattata come una scoperta. Poi però, leggendo la fonte, si scopre che gli autori stessi non sostengono ciò che i giornali attribuiscono loro.
La verità è che, fino a prova contraria, la melatonina è considerata sicura. Lo sappiamo per via diretta: esistono trial clinici ben controllati, svolti negli ultimi vent’anni, che ne hanno testato l’uso a medio e lungo termine anche in popolazioni fragili, compresi bambini con disturbi del neurosviluppo, anziani e pazienti con disturbi del sonno cronici. In nessun caso è emerso un aumento documentato e replicato del rischio cardiovascolare. La farmacovigilanza internazionale – che raccoglie milioni di segnalazioni reali, non dati amministrativi – non mostra alcun segnale di cardiotossicità. Questo non significa che una sostanza debba essere usata a casaccio. Significa che, finché qualcuno non porta un dato serio, valutato con metodi adeguati, riproducibile e controllato, non c’è motivo per gettare all’aria vent’anni di evidenze solide sulla base di un abstract che non supererebbe una revisione statistica preliminare.
La parte triste di questa storia non è l’abstract in sé, che è legittimo come ipotesi di lavoro, ma ciò che accade quando entra nella centrifuga dei social. Un dato preliminare diventa un allarme, un’osservazione parziale diventa certezza, un errore di classificazione diventa una minaccia per la salute pubblica. L’effetto finale è sempre lo stesso: un aumento dell’ansia e della confusione, una perdita di fiducia nella ricerca, un pubblico che non distingue più un trial clinico da un’analisi grezza di database. È esattamente per questo che insisto sempre sul metodo. Gli studi si valutano leggendo le fonti, i dati, i metodi, le assunzioni e i limiti. Non si giudicano per impressione e non si commentano per simpatia. Prima si controlla come è stato fatto lo studio, poi si decide se vale la pena prenderlo sul serio.
Qui, semplicemente, non siamo in presenza di uno studio utilizzabile. È un esercizio statistico preliminare, con limiti talmente marcati da renderlo non interpretabile. E un risultato non interpretabile non deve guidare il comportamento di nessuno. La melatonina continua a essere ciò che è sempre stata: un ormone naturale usato da decine di milioni di persone nel mondo, con un profilo di sicurezza ampiamente documentato. Quando e se arriveranno dati solidi che suggeriscono altro, li valuteremo con la stessa freddezza analitica. Fino ad allora, l’allarme costruito in questi giorni dice molto più sul nostro ecosistema informativo che sulla melatonina.
Continua a leggere...



