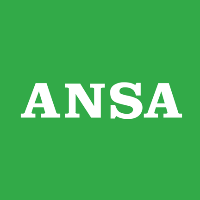Come funziona il missile atomico Burevestnik
- Postato il 27 ottobre 2025
- Di Panorama
- 4 Visualizzazioni


Avrebbe avuto successo il collaudo su lunghissima distanza del missile da crociera 9M730 Burevestnik (codice Nato Ssc-X-9 Skyfall), un progetto innovativo sul quale la Russia ha investito anni di ricerche. Da tempo, infatti, gli Usa seguono i movimenti di personale e mezzi in quello che sarebbe il sito di dispiegamento del nuovo missile, ovvero la base militare Vologda-20 a circa 500 km da Mosca. Si tratta di un’arma con capacità di trasporto nucleare e dotata anche di una propulsione che si affida all’atomo. Il presidente russo Vladimir Putin ne ha parlato come di un missile in grado di confondere le difese nemiche, impossibile da intercettare e in grado di restare in volo anche per 14 ore coprendo distanze mai raggiunte prima, come il volo di oltre 14.000 km avrebbe dimostrato. Le dichiarazioni rilasciate ieri, 16 ottobre, dal Cremlino mostravano Putin in mimetica insieme con il generale Valery Gerasimov, Capo di stato maggiore russo. Ma il Burevestnik, nome dell’uccello delle tempeste, in italiano Procellaria, pare possa restare in volo ancora per più tempo, tanto che Gerasimov ha dichiarato: “Dobbiamo determinare i possibili utilizzi e iniziare a preparare l’infrastruttura per l’impiego operativo di queste armi nelle nostre forze armate”, lasciando intendere uno stato di prontezza ormai quasi raggiunto e la conferma del fatto che il missile abbia una gittata pressoché illimitata e possa percorrere traiettorie di volo imprevedibili. Il progetto era stato annunciato nel 2018 e la quasi totalità gli analisti occidentali era concorde sul fatto che far volare un piccolo reattore nucleare fosse molto pericoloso; inoltre, che durante il volo avrebbe potuto rilasciare radiazioni lungo la sua traiettoria e per questo essere scoperto e neutralizzato. Durante il volo il Burevestnik trasporterebbe una o più testate nucleari, sorvolerebbe il globo a quote altissime come a bassa quota (seguendo l’orografia del terreno), eviterebbe le difese missilistiche e schiverebbe il terreno e sgancerebbe le testate in una o più posizioni difficili da prevedere. In altre parole sarebbe un’arma pericolosa ma che vola a velocità subsonica (inferiore a quella del suono), e ciò lo renderebbe rilevabile e vulnerabile quanto più a lungo rimanesse in volo. Certamente però si tratta di un missile fatto per eliminare del tutto postazioni di comando, basi militari, fabbriche e centrali elettriche nemiche dopo che la Russia avesse già lanciato missili balistici intercontinentali, cioè quando i sistemi di difesa aerea avversaria non sono più in grado di fermarlo.
Tra incidenti e ritardi, come funziona il Burevestnik
Da quanto si conosce di questo progetto, dopo un lancio assistito da un razzo a propellente liquido che lo fa accelerare a una velocità idonea per far funzionare il motore a getto, il propulsore utilizza l’energia di un minuscolo reattore nucleare per riscaldare ed espellere l’aria producendo la spinta. Il progetto non ha avuto una gestazione semplice: nel 2019 diversi scienziati (almeno 5 persone), dell’Agenzia nucleare Rosatom, persero la vita in un incidente durante il recupero di un prototipo di questo missile precipitato al largo di Nyonoksa, nel Mare di Barents. Quel missile, apparentemente lanciato nel 2017, era stato recuperato due anni dopo per consentire all’acqua di raffreddare il reattore e contenere le radiazioni ad alta energia provenienti dal nocciolo. Ma l’acqua di mare, penetrata nel reattore, pare avesse corroso i componenti metallici generando significativi volumi di idrogeno s’incendiò a contatto con l’aria. Un’altra tesi sostiene che lo stadio del booster di lancio fosse ancora attaccato e che il propellente residuo abbia causato l’esplosione danneggiando il nocciolo del reattore e rilasciando il materiale radioattivo. Nel 2021 James Hockenhull, capo dell’Intelligence della Difesa del Regno Unito, affermò che il Burevestnik fosse un missile da crociera subsonico a propulsione nucleare con portata globale basato su un progetto di “statoreattore”. Funziona così: l’aria entra dalla presa d’aria ad alta velocità (da qui il termine statoreattore), viene riscaldata dal reattore nucleare, si espande e spinge il missile in avanti. Il reattore che riscalda l’aria nello statoreattore è la parte nella quale si gioca la partita tecnologica: se si trattasse di un circuito chiuso, dove il calore passa da un elemento all’altro grazie a uno scambiatore, non ci sarebbe fuoriuscita di flusso radioattivo; mentre se il circuito fosse di tipo aperto, il missile lascerebbe dietro di sé una traccia radioattiva e quindi una pericolosa scia. Tante sono le sfide tecnologiche da vincere: il controllo delle temperature, le pressioni, le velocità dell’aria all’interno del motore per citarne soltanto alcune.
I dubbi degli analisti e la contromossa degli Usa
Sono quindi ancora molti i quesiti sui quali gli analisti si stanno concentrando: innanzi tutto il reale stato di sviluppo dell’arma, quindi quali sistemi di mitigazione delle radiazioni sono stati messi in campo per evitare che il missile lasci tracce nucleari durante le operazioni di preparazione. La risposta degli Usa a questa minaccia sarebbe già nel progetto Golden Dome (Cupola d’Oro), ovvero da una serie di satelliti che funzionerebbero da intercettori basati nello spazio, ovvero nella realizzazione in chiave moderna dello Scudo Spaziale di epoca reaganiana. Per questo Trump ha confermato quanto già espresso nel primo mandato con la fondazione della US Space Force (2019), volendo ora costruire uno scudo antimissile che protegga il Nordamerica. Ma rispetto al primo progetto che prevedeva di mettere orbita bassa un alto numero di piccoli satelliti equipaggiati con sistemi di puntamento (anche laser), per raggiungere, colpire e distruggere i missili russi non appena fossero usciti dall’atmosfera, ora si pensa a postazioni ben più complesse e di grandi dimensioni.